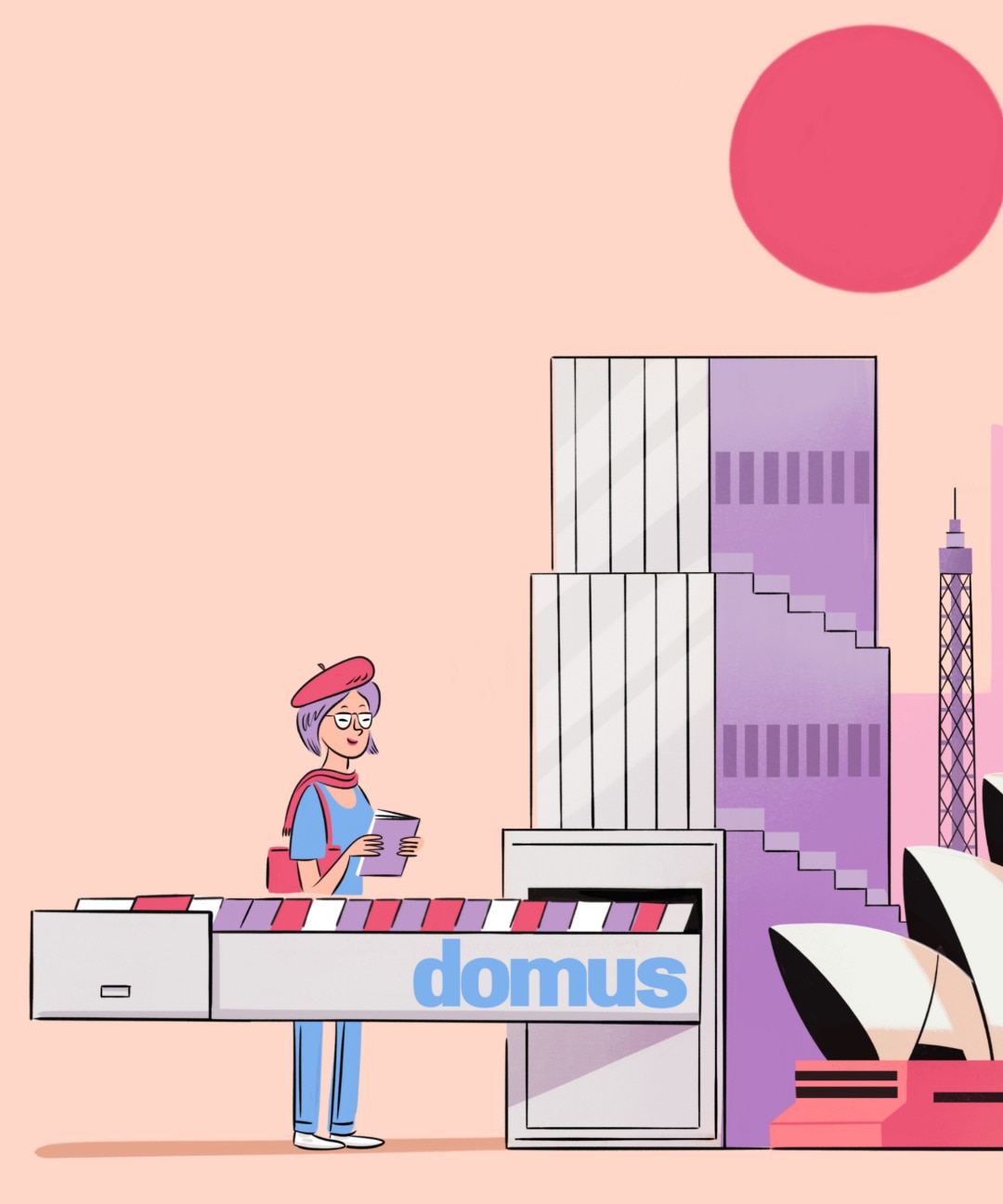C’è un’aria da autobiografia scientifica in questo Napoli Super Modern (nella doppia edizione Park Books, in inglese, e Quodlibet, in italiano, entrambi 2020) di LAN, lo studio italo-francese di Benoit Jallon e Umberto Napolitano con base a Parigi che dopo la fortunata investigazione sull’urbanistica del barone Haussmann (Paris Haussmann, 2017), si dedica ad esplorare il cuore – e l’anima – moderni della città che più al mondo appare imprigionata ai suoi folkoristici cliché.
Impresa non facile, anche perché modernità e architettura a Napoli da sempre sono simboli di speculazione ed eccesso, di interessi non sempre leciti e hybris, in una città sempre troppo slanciata in avanti o troppo ritratta nel suo brodo primordiale. Lo aveva capito uno dei suoi cultori più attenti e appassionati, il compianto storico dell’architettura Benedetto Gravagnuolo, che per Napoli aveva coniato la formidabile definizione di città dell’arcaismo ultramoderno, dove vige un’opposizione temporale mai risolta dei suoi caratteri urbani, quasi che antico e moderno siano destinati a scambiarsi continuamente i ruoli.
La formula del libro è chiara: una città complessa e stratificata come palinsesto, lo sguardo nitido e (apparentemente) neutro della fotografia urbana di Cyrille Weiner, un atlante di disegni e un’impostazione editoriale “svizzera” per un prodotto ben confezionato – magari un po’ algido – destinato ad un pubblico internazionale. Unica concessione la copertina dai colori calcistici, il celeste e il giallo oro del simbolo del Napoli dal 1928 al 1964, che poi è pressappoco l’arco temporale individuato per selezionare 18 edifici a loro modo esemplari della capacità dell’architettura di negoziare ad armi pari un certo rapporto con la città: dal Mercato Ittico di Luigi Cosenza (1929-1935), considerato l’opera napoletana che apre la strada alla modernità, al Palazzo delle Poste di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi (1933-1936), perno della bonifica del Rione Sanità; dal Palazzo d’angolo in piazza Municipio di Marcello Canino, personalità di primo piano sulla scena napoletana anche dopo la fine del regime fascista, al controverso Grattacielo della Società Cattolica Assicurazioni di Stefania Filo Speziale (1956-1958), sorta di “pirellone” che appare nel film Le mani sulla città di Francesco Rosi come quartier generale del costruttore senza scrupoli Edoardo Nottola.

Questo ad uno sguardo in superficie. Ma Napoli non è una città superficiale e richiede una lettura approfondita. E così, affrontando i testi del libro – dello stesso Umberto Napolitano, dell’architetto Gianluigi Freda, dello storico Andrea Maglio, del critico Manuel Orazi: tre napoletani e un marchigiano dallo spirito molto partenopeo – si scopre che il destino Napoli, urbano, sociale, antropologico, persino geologico, è da sempre quello di una costante e tumultuosa dialettica degli opposti che, come un fiume carsico, distrugge e allo stesso tempo alimenta l’energia di una città che si vuole antica e sempre nuova come vuole appunto la sua etimologia, Neapolis.
Napoli è dunque moderna innanzitutto perché rifiuta le banali contrapposizioni ideologiche (la retorica urbana fascista vs quella della ricostruzione postbellica). Al contrario fa della continuità il suo carattere più precipuo. Una continuità non tanto di stile, quanto di atteggiamento, di postura nei confronti della città e dei suoi luoghi. Da nessun’altra parte come a Napoli, infatti, architettura e città sono giustapposte senza la mediazione di un piano, come se qui l’urbanistica non avesse titolo né come scienza per indagare i fenomeni urbani, né come sistema di precetti per regolarli. All’opposto tutto è affidato alla continua appropriazione di luoghi, di spazi dentro e fuori gli edifici, sopra e sotto il suolo urbano che non è mai un piano, proprio perché possiede uno spessore, una tridimensionalità che lo rende ostico ai tentativi di pianificazione. Allo stesso tempo è forse proprio questa conformazione fisica della città ad aver impedito che si affermasse una modernità fatta di modelli idealizzati (Maglio), mentre emerge la capacità dell’architettura di travalicare le categorie su cui si fondano le regole urbanistiche, in primis il rapporto tra spazio pubblico e privato, e trasformarsi in presenza concreta che attesta il divenire della città come continuo “fare” (Napolitano).

A Napoli la città di domani è innanzitutto la città di ieri, non solo come memoria, come monumento, piuttosto come spazio fisico, come luogo abitato, come continuum geologico-tettonico che la storia urbana ha stratificato (Freda), persino come materiale continuamente scavato dove la città si ricostruisce continuamente da sé stessa – come afferma Francesco Venezia, materia ha la stessa radice di madre, mater.
Allora non è sufficiente osservare l’architettura di Napoli da fuori, metterne a fuoco l’immagine. Napoli è una città “porosa”, affermava Benjamin, più volte citato nel libro, dunque occorre esplorarla dentro, nei suoi vuoti, nelle sue cavità pronte a rivelare nuovi significati o accogliere nuovi usi. Da una parte Napoli è super moderna proprio perché le sue architetture si ergono eroicamente sopra la città nel tentativo, più o meno riuscito, di governarne le forze, di comporle – si pensi alla monumentale esedra di Piazza del Plebiscito progettata per contenere l’ingorgo urbanistico della retrostante collina di Pizzofalcone. Dall’altra quella partenopea è una modernità che ha sempre spinto la città oltre sé stessa, in bilico tra la vita e la morte, come ci ricorda la postilla di Manuel Orazi, in territori in cui, come nel celebre antro della Sibilla cumana, l’architettura non è altro che la cassa di risonanza della ritualità della vita umana, “scena fissa delle vicende dell’uomo carica di sentimenti di generazioni”, per dirla con Aldo Rossi, il convitato di pietra del libro.

Lo stile italiano dell’altro mondo
Nata da una joint venture internazionale, Nexion coniuga i valori del Made in Italy a quelli della manifattura indiana. Un sodalizio da cui nasce la collezione di superfici ceramiche Lithic.