George Nakai (Joseph Lee) è un artista americano di origini giapponesi. Da anni lavora senza troppo successo a una serie di sculture che sembrano mille cose già viste, dei fagiolotti zoomorfi di resina puntellati di colori che ricordano un’evoluzione anti-pacchiana dei cani di Jeff Koons, con qualcosa di Kapoor e perché no un tocco di Kusama. Il suo più grande talento non è l’arte, ma l’essere figlio di un grande artista giapponese morto. Artista, o forse sarebbe meglio dire designer: le sue sedute accendono il desiderio degli ultraricchi losangelini in una mostra di opere postume, soprattutto la Tamago chair, una sedia pezzo unico modellata sulle forme del posteriore della madre di George, Fumi Nakai (Patty Yasutake). Che è vivissima, invadente, e abbastanza spendacciona.
.jpg.foto.rmedium.jpg)
L’altra donna della vita di George è la moglie Amy (Aly Wong), che dei due è quella che nella vita ha avuto un po’ di successo, un successo che pare di capire sarebbe stato impossibile senza le ricchezze di partenza messe a disposizione dall’eredità Nakai. La vera creativa dei due comunque è loro: ha riprogettato di persona la splendida casa di Calabasas, un distretto residenziale della San Fernando Valley, a una cinquantina di chilometri dal centro di Los Angeles (ovviamente tutto ereditato). L’azienda che ha creato, uno store di piante apparecchiato con orientalissimo minimalismo e battezzato con poco pretenzioso nome di Kōyōhaus (in cui la “casa” scritto alla tedesca di fonde con “koyo”, che in giapponese sono le “foglie colorate” dell’autunno), è un cult e sta per essere acquisito da una grande catena di casalinghi. Nell’ascesa del feticismo post-Covid per il verde casalingo, sembra proprio la cosa giusta al momento giusto del re-decor delle case dei losangelini. Fin qui probabilmente una clientela snob e borghese con quella spalmata di coattitudine tipicamente L.A., quelli che vanno alle mostre del padre di George per intenderci, domani per tutti.
.jpg.foto.rmedium.jpg)
Già, tutti. Perché non esistono solo gli ultraricchi dalle case perfette e l’arredamento ispirato al feng shui, neanche in California. Tanto meno in questa serie che a raccontarla sembra una storia vera fin qui, un grumo di cliché come se ne sentono tanti soprattutto se nella vostra vita frequentate quell’intersezione dorata tra design da collezione e collezionismo d’arte. Beef, che in italiano è reintitolata come “Lo scontro”, ma che richiama subito i celebri beef dei rapper che spesso hanno trasceso il semplice scontro a parole, è la nuova serie per Netflix di A24, la casa di produzione più hip dell’ultimo decennio – qualche titolo: Ex Machina, Uncut Gems, e il mattatore degli ultimi Oscar Everything, Everywhere, all at once. Con una buona fetta dei protagonisti asiatico-americana, la serie è scritta dal coreano Lee Sung Jin. E come nel celebratissimo film coreano Parasite, la linea di demarcazione tra povertà e ricchezza anche in Beef è in realtà una voragine.
.jpg.foto.rmedium.jpg)
Ecco quindi entrare in scena Danny Cho (Steven Yeun, che amavate alla follia in The Walking Dead). È un personaggio che si muove tra pochi soldi in tasca, business falliti, piccoli ricettatori, qualche sogno criminale, relazioni sentimentali malissimo. È quello che un tempo, con altre categorie, avremmo chiamato un proletario. Di lavoro fa il contractor, ovvero quello che effettivamente le cose (e le case) le costruisce e le ripara, le sa aggiustare anche senza bisogno di arrovellarsi dietro mille tutorial su YouTube sull’iPhone 13 Pro. Le cose che fa sono essenziali, quelle minime e necessarie per abitare. A differenza del cugino Isaac, mezzo malvivente e totalmente un fallito, o del fratello Paul che spende le sue energie tra investimenti in cripto e videogiochi online, Danny Cho è un uomo concreto. E abbastanza arrabbiato con il mondo.
.jpg.foto.rmedium.jpg)
Ma arrabbiati, in Beef, o delusi, o stanchi, lo sono in fondo un po’ tutti. Anche Amy Lau, che reagisce al proprio matrimonio superfancy ma totalmente deludente trastullandosi con maratone autoerotiche con la pistola che ha in cassaforte a casa e lanciandosi in improbabili relazioni clandestine. E infatti tutto comincia nel parcheggio del grande centro commerciale Forsters, dove Danny, il contractor che è lì per comprare cose essenziali per il suo lavoro, e Amy, la donna in carriera che proprio a Forsters vuole vendere il suo business, hanno uno scontro violento che nasce da una sciocchezza e finisce in un forsennato inseguimento in auto che devasta il giardino di un povero malcapitato. Questo scontro tra la ricca e il povero avrà ripercussioni per il resto delle loro vite.
Da quel punto in poi, ogni loro ingegno, ogni loro risorsa, sarà messa a disposizione di un progetto di rivalsa e vendetta. Una guerra per sopraffare l’altro che si combatte lungo le trincee di un mondo sempre più divaricato tra alto e basso, tra ricchezze e pochi mezzi. Da un lato c’è chi del design e dell’arte ha fatto uno strumento di potere e riconoscibilità del proprio status – sociale, finanziario, culturale. Dall’altro, di chi costruisce per necessità, vivendo in maniera quasi parassitaria del surplus di beni dei più ricchi, aspettando che si rompa un tubo o ci sia da fare una piccola ristrutturazione per entrare nei templi del benessere che sono le case dell’1%.
.jpg.foto.rmedium.jpg)
Così, che sia attraverso il potere dividente del denaro o l’organizzazione di una violenza, tra il rimbalzo di decisioni improvvise prese con ira e piani più o meno ben congegnati, tra improbabili sculture e negozi di piante che sembrano gioiellerie e case che si evolvono attorno ai loro protagonisti, l’idea di design che emerge serpeggiando lungo Beef sembra proprio quella di uno strumento di dominio e sovversione al tempo stesso. Dove la bellezza o l’utilità sono solo un paravento e il design è una manifestazione che può essere anche violenta dei ruoli della vita in cui siamo più o meno capitati. Siamo sicuri che questa visione sia così lontana dalla realtà?

L'ultima collezione di Ethimo è una questione di intrecci
Ispirata alle lavorazioni tipiche della spagna orientali e ai patios, la nuova collezione disegnata da Studio Zanellato/Bortotto ripensa l'estetica del comfort.


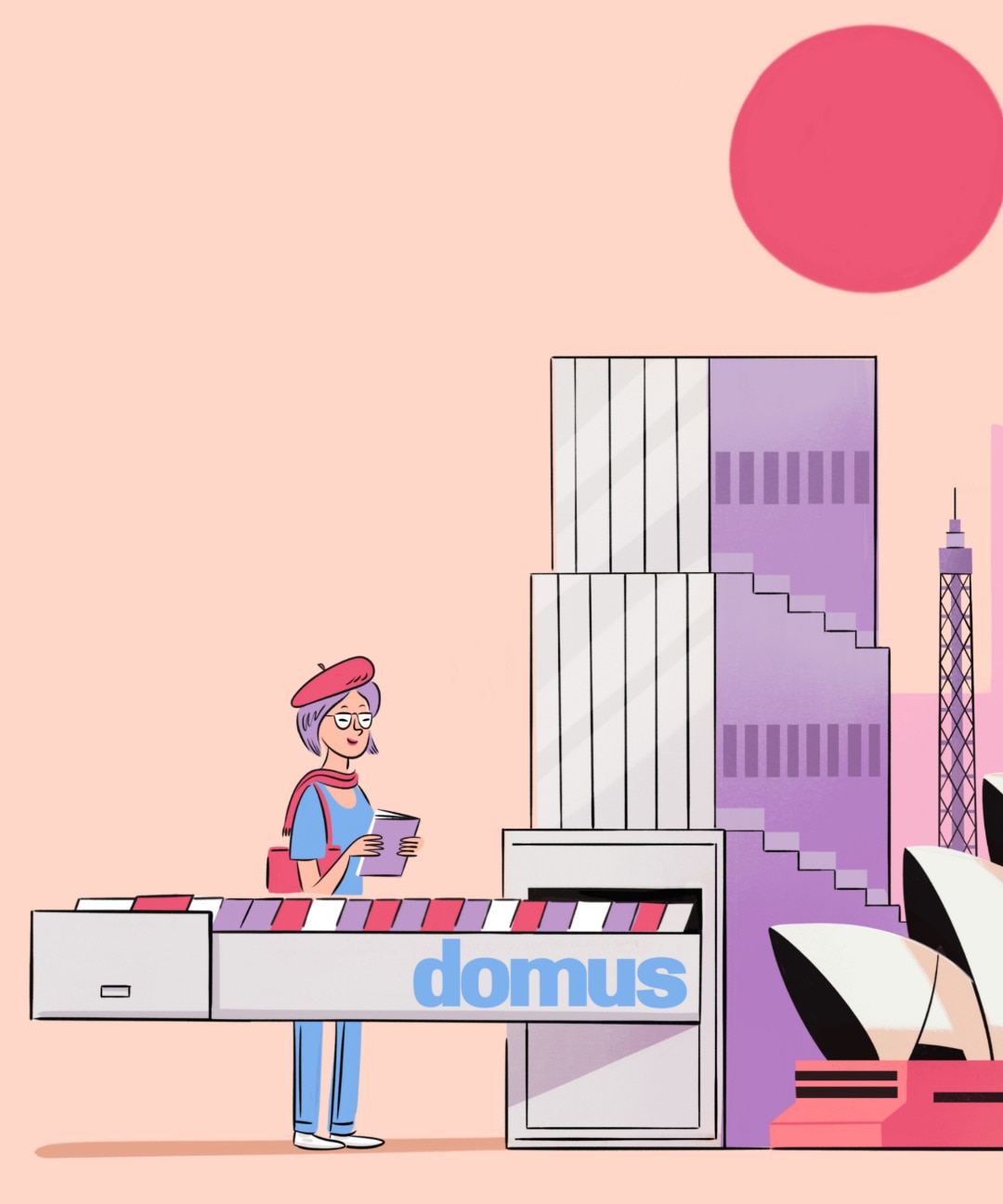
.jpg.foto.rmedium.jpg)
