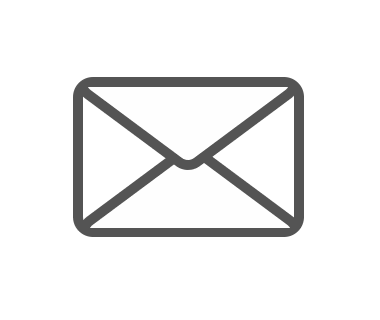Una torre dell’acqua è un oggetto dove i principi della fisica e le sperimentazioni poetiche del progetto d'architettura si trovano ad avere, come capita raramentem lo stesso peso.
Di per sè, quella che chiamiamo torre piezometrica è un serbatoio idrico pensile: un serbatoio in quota che distribuisce acqua a diversi punti secondo la legge di gravità e il principio dei vasi comunicanti. L’acqua accumulata in quota può essere distribuita in più zone simultaneamente grazie alla maggiore pressione, purché l’altezza della torre sia almeno pari a quella dei punti da servire.
Lo schema funzionale di stoccaggio, captazione e distribuzione è quindi oggettivamente fissato, ma è nella sua espressione architettonica che subentrano molteplici variabili capaci di influenzare le scelte compositive: caratteristiche topologiche e di entità del bacino d’utenza, poi la posizione, l’altezza del manufatto, le dimensioni del serbatoio.
Ancora più soggetto ad alea è il progetto dell’involucro, non strettamente vincolato a logiche meccaniche e quantitative, che nel corso del tempo ha dato luogo a variegate esplorazioni espressive da parte di architetti e ingegneri. Dalle realizzazioni schiettamente funzionali situate storicamente vicino alle stazioni ferroviarie per rifornire le locomotive a vapore (Torri Piezometriche della Stazione Termini, Torre Arcobaleno), a quelle più recenti per contrastare l’emergenza idrica in aree disagiate (Warka Tower), nel tempo la tipologia della torre piezometrica si è evoluta da semplice “infrastruttura di servizio” ad “architettura” che si impone in modo incisivo nel territorio da un punto di vista sia figurativo sia comunicativo.
È il caso di landmarks iconici che spaziano nel linguaggio architettonico – dal Neogotico (Chicago Water Towers), al Brutalismo (Cranhill Water Tower a Glasgow, Chateau d'eau de La Source a Orléans, Midrand Water Tower a Johannesburgh, StormWater Facility a Toronto), al Futurismo (Centro idrico EUR a Roma) – e di opere che adottano un design insolito e accattivante per potenziare l’ identità del luogo e della funzione che svolgono: funghi macroscopici (Water Towers a Kuwait City), merletti industriali (Château d’eau Ban de Gasperich in Lussemburgo), pesche giganti (Peachoid in Illinois) e sfere antigravitazionali (Union Watersphere in New Jersey) che punteggiano il paesaggio urbano e si ergono lungo trafficate arterie di transito come totem pubblicitari.
Se oggi molte torri dell’acqua sono in disuso o in decadimento per via della trasformazione di processi e tecnologie (Svaneke Water Tower), e se il mercato del riuso edilizio guarda spesso a questa tipologia con intellettualistico interesse (anche se con esiti alterni), resta indubbio il fascino spiccio di queste emblematiche architetture di servizio, talvolta ancora attive nelle finalità originarie e talvolta relegate a utensili rotti in attesa di nuova funzione per non essere dimenticati.

Ancora più soggetto ad alea è il progetto dell’involucro, non strettamente vincolato a logiche meccaniche e quantitative, che nel corso del tempo ha dato luogo a variegate esplorazioni espressive da parte di architetti e ingegneri. Dalle realizzazioni schiettamente funzionali situate storicamente vicino alle stazioni ferroviarie per rifornire le locomotive a vapore (Torri Piezometriche della Stazione Termini, Torre Arcobaleno), a quelle più recenti per contrastare l’emergenza idrica in aree disagiate (Warka Tower), nel tempo la tipologia della torre piezometrica si è evoluta da semplice “infrastruttura di servizio” ad “architettura” che si impone in modo incisivo nel territorio da un punto di vista sia figurativo sia comunicativo.
È il caso di landmarks iconici che spaziano nel linguaggio architettonico – dal Neogotico (Chicago Water Towers), al Brutalismo (Cranhill Water Tower a Glasgow, Chateau d'eau de La Source a Orléans, Midrand Water Tower a Johannesburgh, StormWater Facility a Toronto), al Futurismo (Centro idrico EUR a Roma) – e di opere che adottano un design insolito e accattivante per potenziare l’ identità del luogo e della funzione che svolgono: funghi macroscopici (Water Towers a Kuwait City), merletti industriali (Château d’eau Ban de Gasperich in Lussemburgo), pesche giganti (Peachoid in Illinois) e sfere antigravitazionali (Union Watersphere in New Jersey) che punteggiano il paesaggio urbano e si ergono lungo trafficate arterie di transito come totem pubblicitari.
Se oggi molte torri dell’acqua sono in disuso o in decadimento per via della trasformazione di processi e tecnologie (Svaneke Water Tower), e se il mercato del riuso edilizio guarda spesso a questa tipologia con intellettualistico interesse (anche se con esiti alterni), resta indubbio il fascino spiccio di queste emblematiche architetture di servizio, talvolta ancora attive nelle finalità originarie e talvolta relegate a utensili rotti in attesa di nuova funzione per non essere dimenticati.