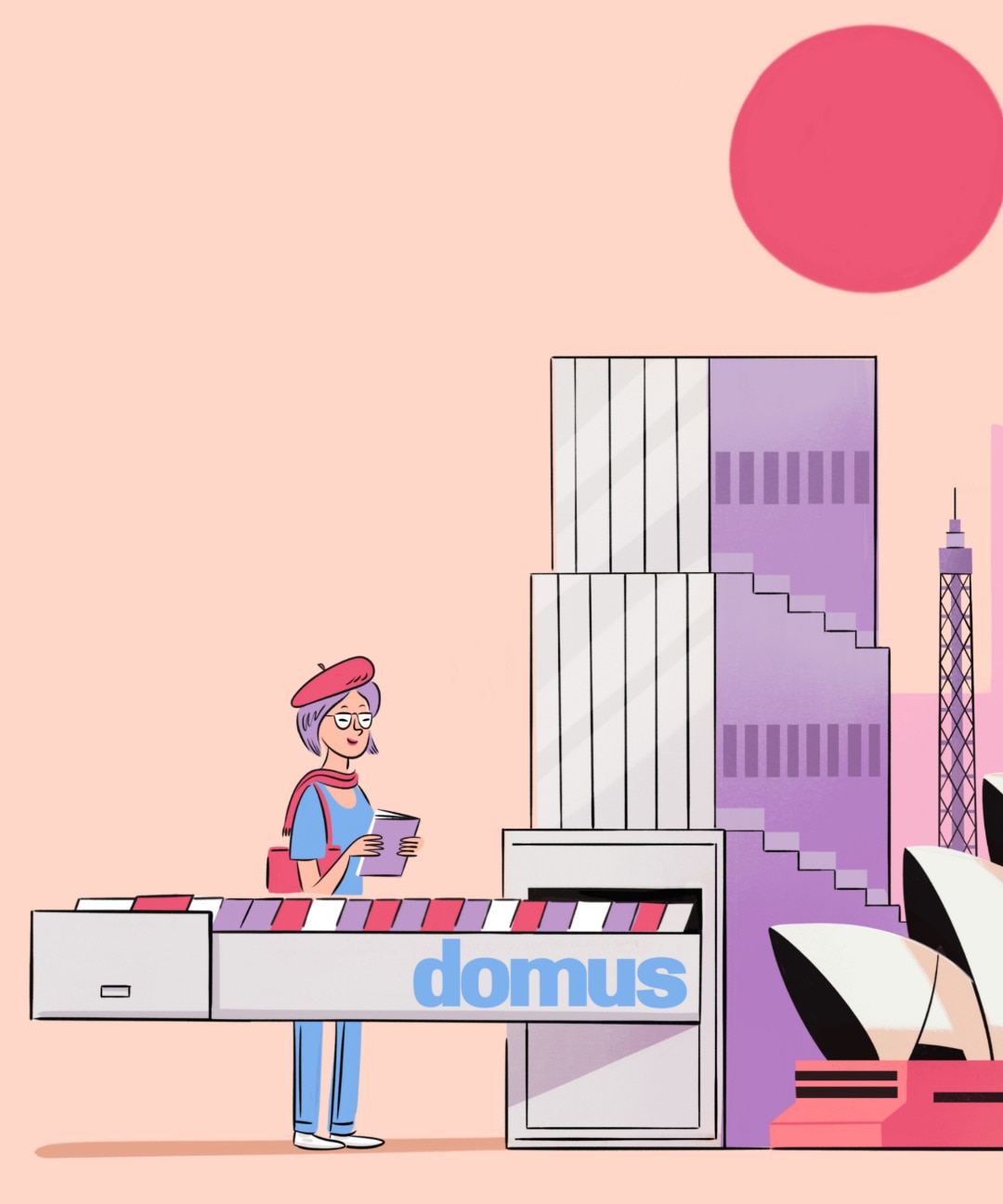Una vista aerea: palme, cupole ricoperte di maioliche dorate, si sfuma sugli interni del casinò dove Loretta Goggi si avvicina spregiudicata a un tavolo da gioco cantando Io nascerò. Questo lo scenario televisivo 1986, ma lo si può replicare a piacimento, roulette più roulette meno, fino a oggi, sostituito al massimo da un più generoso drone. È in ogni caso l’immagine più completa che possiamo ottenere della città di Sanremo nei sei giorni di festival che la rendono capitale culturale d’Italia.
A sfuggire potrebbero essere le due città (se non addirittura tre) che fondendosi rendono possibile una trasformazione impensabile altrove: una composta località di riviera diventa un dispositivo situazionista, una macchina della comunicazione che con le sue antenne temporanee e i watt a disposizione dei suoi impianti audio fa impallidire il Centre Pompidou nelle sue prime formulazioni. Una città-macchina che ora si estende anche in mare con una nave da crociera che diventa un Fun Palace, quasi una “Floating City” degna degli Archigram. In fin dei conti, una New Babylon che, come la città situazionista pensata da Constant Nieuwenhuys, fluttua sopra una materia esistente e statica.

Il festival è una araba fenice, rinato da ceneri sempre più incenerite almeno due volte tra i ’70 e oggi, che può esistere e rinascere solo in un luogo come Sanremo: araba Fenice pure lei, che però dentro le sue ceneri sembra stare benissimo, senza particolare voglia di scrollarsele se non in recenti tempi di superbonus edilizio.
Ce lo ha raccontato anche Emiliano Colasanti, A&R executive dell’etichetta indipendente 42 Records. Lui il suo primo festival lo ha fatto da giornalista, nel 2000, e adesso che partecipa al suo sesto da produttore, con Colapesce e Dimartino, conferma che della città sarà sicuramente cambiata la geografia umana strettamente legata alla musica, ma non certo quella fisica, non parliamo poi di quella edilizia: “ti ritrovi diviso tra tre città, quella stretta attorno ai due isolati del festival, quella antica perfettamente indifferente, e poi tutto quel mondo lussuoso e decadente, i grandi alberghi e le ville, una sfumatura di Twin Peaks”.

Perché quella materia su cui si stende il situazionismo del Festival è in realtà una materia nata rapidamente, e rapidamente cristallizzata, quella che ha disteso su tutta l’area della Foce e sulle colline che la chiudono le grandi ville di una élite internazionale attratta dalla riviera dei fiori a fine Ottocento, lo scomparso castello Marsaglia, il castello Devachan, la villa in cui Alfred Nobel ha concluso i suoi giorni nel 1896, lasciando un giardino che si salda con la villa Ormond retrostante e concede al pubblico una piccola quota di quella decadenza che sembra essere il materiale costruttivo dell’intera città. Sono poi arrivati i grandi alberghi, il Londra, il des Anglais, il Royal, a volte a sostituire le ville, oggi a estendere il primo Novecento in un secolo successivo (viene quasi da declinare l’offerta del wifi per non rovinare la time capsule), e molto spesso a offrire alla vista le loro masse un po’ appannate dal tempo. “Le facciate vengono rinnovate col 110 (il bonus edilizio), gli interni sono sempre loro”, dice sempre Colasanti.

Una materia fastosa e atemporale che concede l’accesso a pochi nuovi eletti, si tratti delle persone del festival, oppure di un pugno di episodi del Moderno: la piscina proprio del Royal, mosaici e forme organiche con cui Gio Ponti negli anni ’50 porta avanti i fasti della grande villeggiatura; la marina di Capo Nero di Luigi Carlo Daneri, che all’inaugurazione delle sue masse astratte ancorate tra onde, roccia e pini (con qualche concessione brutalista), si prende i complimenti di Le Corbusier; e poi c’è l’Ariston.

Ottantenne quest’anno, il cinema teatro che dal 1977 ha portato via al Casinò il sancta sanctorum, il palco del Festival, ci consegna un’altra time capsule, dalle sue forme originarie definite da Marco Lavarello negli anni 50 – tra soffitti “plissettati”, illuminazioni a grappolo, prototipi firmati Barovier e Toso – che respirano l’aria della ripresa e dell’ultima stagione dei piroscafi, fino a quelle quasi illeggibili di oggi, in cui è il core della macchina-Sanremo. È la scatola di un palcoscenico sempre più mastodontico e sonoramente tecnologico (possiamo alla buon’ora parlare, dopo 7 decenni, di uno stile rai?), della classica scala – che a scenderla siano Freddy Mercury o Patty Pravo in japonisme Versace – e di un altro feticcio semiotico, i fiori che nel 2023 hanno trovato un utilizzo inconsueto, calciati da Blanco attraverso tutto lo spazio disponibile.
Ma c’è poi quell’altra città, quella presente fin dall’inizio e ugualmente impermeabile alla trasformazione Belle Epoque e a ogni Festival che la storia manda in terra, comincia appena si lascia la via Palazzo, si passa sotto un muro di case e dalla piazza subito dietro si comincia una salita di gusto alpinistico in strade che, coperte da piani e piani di abitazioni, non vedono la luce del giorno, grotte medievali che si aprono in piazze da cui il clamore dei live e degli eventi si può solo sentire e non vedere, spesso con risultati ancora una volta vicini alla science-fiction: è la Pigna, la città alta dove raramente la geografia umana del festival si inoltra, che a tanti, Colasanti compreso, può capitare di scoprire solo dopo parecchi anni di frequentazione.

Rappresentazione plastica di quella velocità doppia che vive Sanremo, che se da una parte si sbarazza della ferrovia litoranea riavvicinandosi a un mare altrimenti lontano dal cuore della città, dall’altra incastona la nuova stazione nel profondo della collina, arricchendosi di un'altra caverna da cui ruscellano trolley e persone a flusso continuo, un altro pezzo fondamentale della macchina situazionista.
Vissuta da Festival, Sanremo è un’entità mentale, tanto da potersi staccare da quei limiti fisici che sembrava volessimo cercare: non dimentichiamoci che già nel 1990 il Festival di Sanremo lo si è fatto ad Arma di Taggia, poco distante ma comunque non Sanremo. Il Palafiori - quello vero, non il centro congressi poco distante dall’Ariston - è un capannone dell’enorme mercato dei fiori di Valle Armea, che si faticò a riempire e dal cui soffitto non si riuscirono a cacciare i pipistrelli, neanche durante le dirette, con buona pace di Liza Minnelli ospite quell’anno.

Senza che la si possa collocare precisamente, ad oggi, quella presenza da megastruttura continua assieme alla Pigna a ricevere l’eco dei sei giorni più rumorosi del Paese, e con le facciate Liberty e le piscine organiciste a far parte di una psicogeografia senza la quale niente di tutto ciò sarebbe possibile. In buona sintesi, perché Sanremo è Sanremo.

Innovazione e sostenibilità nei materiali da costruzione
La nuova gamma di intonaci termici a base calce di Röfix è progettata per offrire soluzioni avanzate di isolamento.