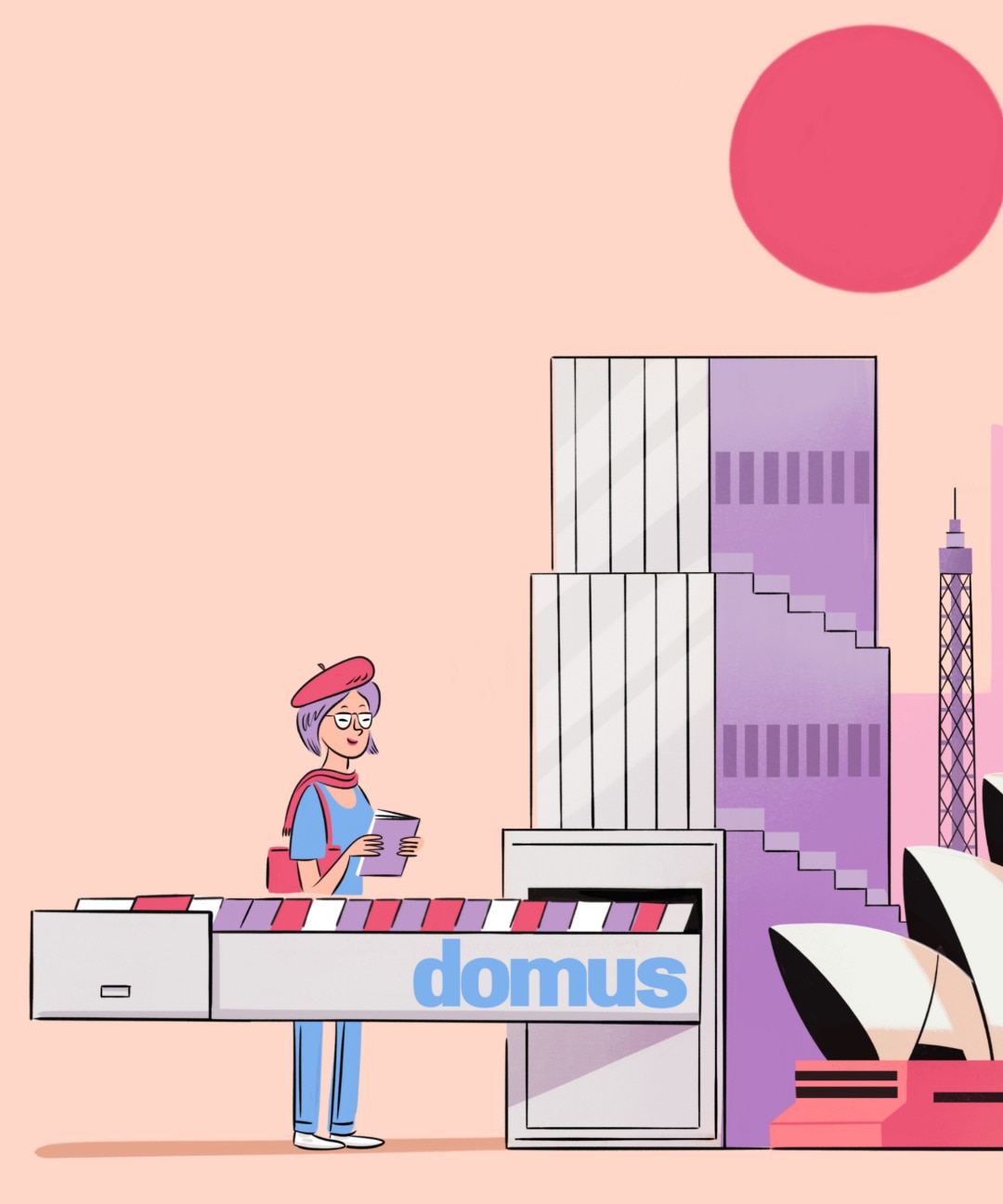Con il suo immancabile sorriso ironico, Gianni Pettena ama spiegare che se in genere i suoi colleghi architetti hanno costruito solo una parte, spesso minima, dei progetti disegnati, lui, nel corso della carriera, ha costruito “tutto tutto tutto (o quasi). “E in scala 1:1”, aggiunge, con una frecciata agli amici architetti radicali, che spesso hanno sostituito alla realtà della costruzione il simulacro del plastico o del fotomontaggio.

L’anarchitetto Pettena ama i paradossi, perché se è vero che ha potuto realizzare la quasi totalità dei suoi progetti, bisogna precisare che questi progetti non sono edifici o architetture in senso tradizionale ma installazioni, ambienti, performance. E tuttavia, anche se assumono le forme dell’arte – non ricalcando ma spesso anticipando i modi della Land Art o della performance, o delle pratiche partecipative –, tali progetti sono, per Pettena, pur sempre architettura. Anzi sono la sola architettura possibile: intesa non come l’esercizio di una razionalità normativa e di un dominio dell’uomo sulla natura, ma al contrario come una pratica di adattamento all’ambiente, come un gesto che, invece di rivendicare l’autonomia e l’autorità del progettista, e, più in generale, dell’essere umano, ribadisce i legami di interdipendenza che lo legano al mondo.

Mi sembrava naturale interessarmi al cinema e al teatro sperimentale, esplorare le pratiche contemporanee che ripensavano i linguaggi visivi ma anche le coordinate dello spazio.
“Tutto tutto tutto (o quasi)” è il titolo scelto da Pettena per la monografia, recentemente uscita da Quodlibet. Il volume, di più di 500 pagine, documenta, per la prima volta, l’insieme dei progetti e una buona parte dei testi teorici dell’architetto, dagli anni Sessanta a oggi. A partire dalla visione panoramica che il libro permette, il percorso di Pettena appare in tutta la sua coerenza e complessità. Bolzanino di nascita, fiorentino d’adozione, non solo un indiscusso protagonista della stagione radicale ma né è anche uno dei più autorevoli esegeti.

Ma non smette di rivendicare la sua autonomia e il suo scetticismo. Studente insieme ai membri di Superstudio e Archizoom alla Facoltà di Architettura di Firenze negli anni Sessanta, in cui matura la rottura dal verbo modernista, si accorge rapidamente, come ama raccontare “che era solo una scuola professionale per ottenere la licenza di architetto, per il professionista che viene educato a fare stare in piedi degli edifici, a organizzare razionalmente gli spazi, ma che se ne frega del linguaggio, dei materiali, degli abitanti. Una scuola di obbedienza assoluta, che insegna non la libertà ma le limitazioni che una certa idea di società impone all’architettura”.

Allora, preferisce frequentare le gallerie d’arte – non solo a Firenze ma a Milano o a Torino, da Gian Enzo Sperone, o a Roma, da Sandro Gentili –, o a seguire i readings dei poeti della Beat Generation invitati da Fernanda Pivano in giro per l’Italia. Come spiega: “mi sembrava naturale interessarmi al cinema e al teatro sperimentale, esplorare le pratiche contemporanee che ripensavano i linguaggi visivi ma anche le coordinate dello spazio. Tra gli anni Sessanta e Settanta, gli artisti dell’Arte povera o i giovani della Land art, come Robert Smithson – che conobbi a Roma, nel 1969 e con cui pubblicai su Domus una conversazione, nel 1972 – stavano elaborando nuovi modi di pensare lo spazio, di connettere l’uomo con il contesto, urbano e naturale. Soprattutto, gli artisti con cui mi relazionavo, con cui stringevo amicizia, erano quelli che usavano il linguaggio visivo in presa diretta col divenire della cultura della mia generazione e che sperimentavano nuovi modi di fare arte, come performance e installazioni. Io, che avevo una forma di ipersensibilità verso l’architettura, un’attenzione specifica alle questioni dello spazio e dell’ambiente, mi trovavo perfettamente integrato con loro. Ci ponevamo le stesse domande ed esploravamo campi limitrofi.”

Se andavo d’accordo con gli artisti, al contrario, ero quasi sempre in disaccordo con gli altri architetti…
Negli anni Settanta, al contrario di molti colleghi radicali, non cede alle lusinghe del design e, invece di spostarsi a Milano per lavorare con le industrie, parte per gli Stati Uniti, dove esplora i deserti ed entra in contatto con la scena dell’arte sperimentale, ritrovando, tra gli altri, Lawrence Alloway e Robert Smithson. Nel momento in cui il MoMa di New York, con l’esposizione “Italy: the New Domestic Landscape” (1972), sancisce il trionfo internazionale dell’architettura e del design italiano, con uno spirito pungente di provocazione, Pettena espone, sempre a New York, alla galleria John Weber, delle foto dei deserti americani scattate durante i suoi viaggi. Lo stesso spirito di contraddizione lo spinge, l’anno dopo, nel 1973, al momento della foto ricordo per la fondazione di Global Tools, progetto di scuola alternativa che voleva riunire le diverse anime radicali, a tirare fuori un cartello con su scritto Io sono la spia.

Ancora oggi rivendica questa presa di distanza: “Se andavo d’accordo con gli artisti, al contrario, ero quasi sempre in disaccordo con gli altri architetti… e questo spiega anche la mia grande amicizia con Ettore Sottsass. Perché lui aveva rivoluzionato non solo le forme ma anche il pensiero dell’architettura, reintroducendo materia, colore, azione e decorazione nella piattezza del Modernismo, che articolava esclusivamente funzioni nella prospettiva dell’evoluzione delle tecnologie e della rivoluzione industriale”.
Per Pettena, il Modernismo aveva ridotto l’architettura al minimo, a pane e acqua. “Mentre il menu dell’architettura è sempre stato ricchissimo”, continua: “per l’architettura il reale non è il razionale, ma è la lotta quotidiana tra razionale ed emozionale – una dialettica che fonda l’evoluzione della cultura in generale. Ed è questa dimensione che cercavo all’epoca – e ancora oggi” In questo però non trovò compagni di strada tra i Radicali, “perché in realtà la loro radicalità era spesso di facciata”, dice. E soprattutto perché preferivano elaborare, continua, proposte teoriche o fotomontaggi, rifugiandosi in studio, rinunciando alla costruzione (o realizzando, poi, architetture commerciali), rinunciando al mondo. Essere radicali significa andare alle radici, riconoscere l’architettura nel mondo, nella natura… persino nel deserto!”

Animato allo stesso tempo da un esuberante e vitale entusiasmo e da una rigorosa intransigenza, Pettena si sente invece vicino agli artisti concettuali americani che con cui dialoga sin dagli anni Settanta. Ma soprattutto, è fra i primi a introdurre nella sua ricerca una dimensione ecologica, che si configura come una pratica d’implicazione nell’orizzonte naturale, poco comune nelle riflessioni dei radicali italiani. Come ricorda: “Tutto il mio percorso è stato influenzato dalla forte presenza della natura, delle Dolomiti, dello scenario della mia infanzia. Anche quando non sembra visibile, quest’influenza è presente, a livello inconscio. Come nel divano Rumble, uno dei miei primi progetti e uno dei miei rari progetti di design (ora in produzione da Poltronova): l’ho pensato come una specie di nido, dove togli i cuscini e ci entri dentro con gli amici. All’epoca – era il 1967 – avevo disegnato una decina di lampade tutte attorno che erano degli alberi stilizzati, ma me ne son accorto trenta anni dopo! Avevo fatto un’allegoria della natura anche nella mia prima architettura!”

Per l’architettura il reale non è il razionale, ma è la lotta quotidiana tra razionale ed emozionale – una dialettica che fonda l’evoluzione della cultura in generale.
Invece di spingere verso un pauperismo moralista o di indulgere in dimostrazioni retoriche, i lavori di Pettena hanno la semplicità di gesti elementari che non annullano la cultura per ritrovare il culto di una natura incontaminata, né idealizzano la cultura in freddi esercizi retorici. Non dei gesti che tendono a lasciare una traccia, a incidere un segno sulla superficie del mondo, per attribuire un senso all’uomo e al mondo, ma al contrario dei gesti che sono incorporati dall’ambiente, che proiettano la propria sparizione, che assumono la fragilità dei corpi, degli eventi e del linguaggio.

In questo senso, la sua opera è oggi riscoperta come quello di un pioniere non solo nel mondo dell’architettura ma anche dell’arte contemporanea. Sempre di più, infatti, musei e gallerie (come Salle Principale a Parigi, che ne diffonde i lavori) presentano gli anti-progetti di Pettena: come scrive, dei “progetti effimeri, reversibili, il cui valore è a volte solo documentario: un’architettura mentale che spesso si traduce in esperienza fisica, creando o rinnovando la necessità del rapporto con l’ambiente” (p. 27). In questi progetti, una coscienza ecologica profonda fonda un metodo che salda insieme sensibilità per la forma, attenzione al contesto e tagliente esigenza concettuale. Senza mai perdere l’ironia.

L'ultima collezione di Ethimo è una questione di intrecci
Ispirata alle lavorazioni tipiche della spagna orientali e ai patios, la nuova collezione disegnata da Studio Zanellato/Bortotto ripensa l'estetica del comfort.