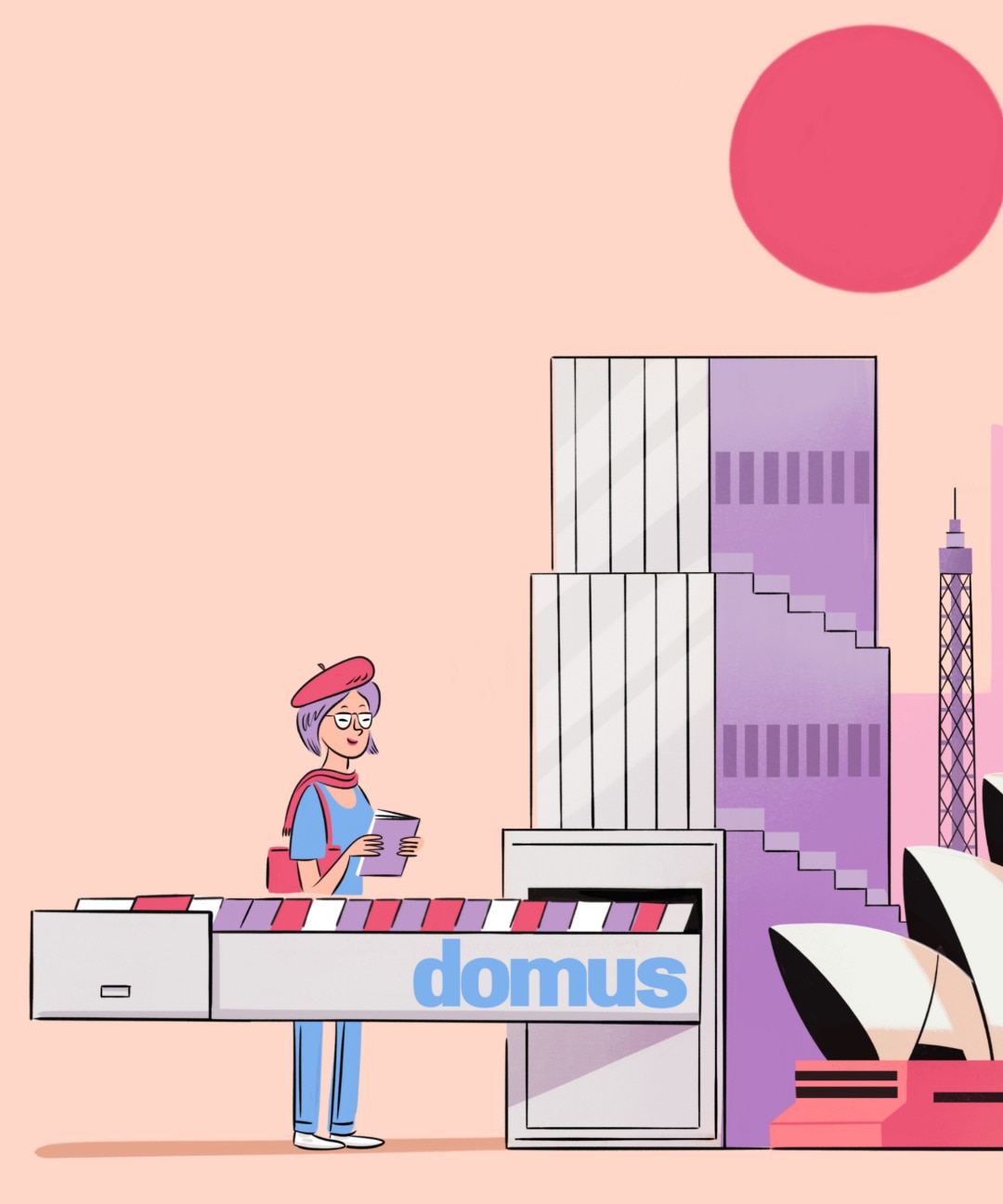Avete da poco rinnovato la vostra sede, un luogo di lavoro ideale. Mi puoi raccontare come è nata la necessità di uno spazio di proprietà?
La sede attuale di LAN è nata non solo dalla necessità di più spazio - al tempo avevamo vinto il concorso per il Grand Palais - ma coincideva con il bisogno di pensare a uno luogo che non coincidesse esclusivamente all’idea di ambito lavorativo. Una parte determinata dello studio coincide con una metodologia di sviluppo progetti a noi nota, consolidata. Un piano quindi espressamente dedicato a team di progettazione. Il piano superiore invece è uno spazio flessibile e aperto in funzione di come sta evolvendo il mondo del lavoro. Un luogo in forte connessione con lo spazio esterno, con la città, per elevare la qualità del quotidiano a una forma quasi domestica e confidenziale dello spazio. I tempi del progetto privato non corrispondono più alle fasi alle quali eravamo abituati 10 anni fa. Si generano meccanismi che prevedono periodi molto intensi seguiti da fasi completamente inattive in attesa che il progetto venga finanziato, quindi dopo sei mesi si riprende e sempre con lo stesso team, che non può rimanere in stand-by. Da qui la necessità di una struttura elastica che evolve e permette composizioni di team flessibili e per molteplici progetti.Volevamo un spazio in grado di offrire le migliori condizioni per immaginare collaborazioni tra professionisti nel lungo periodo. L’area di progettazione, l’atelier maquette, il laboratorio di ricerca, e ogni unità di produzione coincide con l’idea di una esperienza aperta e raggiungibile da ogni collaboratore. Si cerca di lottare contro l’iper-specializzazione degli architetti senza limitarci a univoche prestazioni professionali come la partecipazione dei concorsi o la gestione di cantieri. Intendiamo diversificare e offrire un’esperienza non ripetitiva in un luogo altamente confortevole, dove il confronto tra i team e l’esito dei progetti dei team diviene un tema di dibattito e confronto interno. Viceversa non riusciremmo ad arricchire quella dimensione professionale che in architettura nasce con ampissimo respiro ma che poi di frequente finisce nell’incanalarsi in competenze troppo specifiche e a lungo andare sterili.

In quale modo il metodo di lavoro di LAN si concilia con quello che sta accadendo oggi?
Una nostra priorità è quello di capire chi siamo, chi sono le persone che gravitano attorno a LAN e che partecipano al nostro processo creativo. E’ una esigenza fondamentale per costituire la realtà dello studio di oggi, senza la quale non troveremmo appigli. Capire le esigenze di ognuno di noi è una via di fuga rispetto modelli impersonali e generici di condivisione delle esperienze lavorative. L’efficienza di uno spazio basato su un modello taylorista non è più un obiettivo se esclude l’empatia con le persone, con chi partecipa. Lo scambio è quindi fondamentale su una prospettiva che sia meno dogmatica possibile, dove tutto deve coesistere - per riprendere lo slogan elettorale di Macron. Viviamo una società fortemente plurale oggi. L’approccio e il metodo unico in Architettura quale risultate causa-effetto, ovvero il modello basato su progresso, funzionalismo, è a mio avviso superato oggi dalla possibilità di scelta. Di moltitudine di aspettative, soluzioni, combinazioni di realtà anche molto contraddittorie. Lo scambio quindi, in un contesto governato da tante verità, è più che mai necessario, più che mai abbiamo bisogno di punti di vista, di interessi, di interazioni di culture estremamente differenti. Non a caso, un tema di ricerca teorico sviluppato nel laboratorio intende porre il paradosso quale strumento critico del contemporaneo. Il paradosso di far coesistere realtà totalmente opposte, e qualsiasi riflessione in merito, non può che essere vincolato a un modello di studio, tempo, lavoro e scambio più che mai tangibile, fisico. E questo coincide anche con la metodologia progettuale di LAN, dove ogni progetto prescinde da una speculazione intellettuale, dal significato, e non dal disegno. Il disegno viene successivamente a uno scambio sul significato di un termine, di una parola capace di definire il senso della proposta e di esistere senza il disegno. Reinventare il processo del lavoro deve partire dall’idea che non c’è un solo modo, una sola verità, e che in realtà forse lo spazio più incerto è quello più interessante.
I vostri progetti hanno spesso a che fare con interventi urbani consistenti. Offrite soluzioni sofisticate nella loro diversità. Come siete arrivati a questo controllo?
Dal vostro sito, dalle pubblicazioni, emerge una grande lucidità. Dall’inizio abbiamo cercato di porre le scelte linguistiche quali condizioni di arrivo e non di partenza. Qualsiasi scelta tecnologica o di materiali deriva da un approccio laico, senza preconcetti, e perciò ammette tutto: ma questo non implica l’impossibilità di sviluppare un proprio vocabolario. L’esplorazione di linguaggio come tema a lungo termine della propria ricerca, il cemento per Tadao Ando, ad esempio, porta a una conoscenza senza dubbio inarrivabile, non accessibile ad altrui. Sotto questo punto di vista abbiamo sempre cercato forme di contrapposizione, semmai incentrate a considerare la forma quale una delle risultanti finali di questo processo. Una ricerca della forma quale sintesi di contraddizioni, strategie, scelte, in linea col pensiero degli Smithsons che definisce gli architetti quali form-givers ovvero danno forma a delle idee ma soprattutto donano nuove forme di esperienze nel momento in cui gli edifici vengono abitati e praticati dagli utenti.

Nella produzione di architettura di oggi c’è la tendenza a un prodotto a volte forzatamente ecologico, doverosamente ambientale. Se non attuato con estrema serietà, si rischia una cosmesi per sopravvivere al mercato. In che modo questa ossessione del green ha condizionato il vostro approccio metodologico?
È una domanda molto complessa. Il modo in cui il progetto è veicolo di comunicazione - politica, identitaria, o di mercato - fa parte della regola del gioco nel momento in cui si riesce a prenderne le distanze. Esiste in effetti oggi una necessità di sopravvivenza contro cui abbiamo lottato a canoni inversi, con un rifiuto a priori di una utilizzazione di parametri legati all’ecologia in modo così mercantile e dogmatico. Una contrapposizione che ha invece promosso temi di ricerca come quello su Haussmann dove l’indagine del tessuto edilizio è anche un modo per evidenziare che le vere sfide ecologiche ed economiche portano a un insieme di parametri dove comunque l’architettura deve inserirsi per quello che esprime. È chiaro che si tratta un equilibrio tra densità urbana, natura, servizi, energia, economia e bisogni sociali che però a nostro avviso sono parametri da equilibrare in una riflessione che comunque deve portare necessariamente a esprimere un linguaggio architettonico. È un discorso che diventa pagabile nel momento in cui si riesce a comunicare, quasi come in un processo pedagogico, la complessità dell’opera.
In che modo la pandemia ha impattato il progetto del Grand Palais e la vostra metodologia di lavoro?
Abbiamo iniziato a lavorare al progetto dal 2013 ed ora è stato ufficialmente fermato al termine della fase progettuale, che corrispondeva all’inizio della gara d’appalti e la gestione del cantiere. È stato molto interessante perché abbiamo imparato a gestire un’opera complesse, assieme ai migliori decisori. Ci ha permesso di confrontare i limiti del processo pubblico rispetto al privato, anche in termini di qualità. Nel pubblico il processo decisionale è molto intricato ma ti permette di non fare errori che accadono nel privato dove le scelte vengono testate meno volte. Sul progetto del Grand Palais ci siamo strutturati come uno studio nello studio. Dover porre fine a un progetto su cui hanno lavorato cento persone in sette anni porta a delle interessanti riflessioni sul modo di fare e produrre architettura ad una certa scala. Al di là della delusione di non vederlo realizzato, è stata un’esperienza incredibile, di grande apprendimento.

Al piano terra dell’edificio che ospita i vostri nuovi uffici c’è un ristorante chiamato, appunto, Piano terra. Rappresenta uno stile di vita, una attitudine?
Da LAN, e quindi per estensione anche al ristorante Piano terra, ricerchiamo un’alleanza tra piacere, idealismo ed esperienza diretta. Prendendo coscienza del quotidiano ci si accorge che avere ideali lungimiranti è plausibile, ma la qualità della vita è fatta da frammenti di situazioni qualitative che si elaborano a lungo termine e si sommano giorno per giorno. Il nostro intento è allineare una qualità di produzione e di vita, avanzando ogni progetto nelle due dimensioni. Durante i primi anni lo studio era un luogo in cui passavamo 24 ore su 24, completamente focalizzati nell’azione produttiva. Negli ultimi tre anni, evolvendo a pari passo con la società, durante interviste con architetti in cerca di lavoro mi è stato domandato qual era il progetto del tipo di vita dello studio, indipendentemente dal progetto architettonico. Le nuove generazioni cercano di associare tempi di lavoro ad ambizioni in una nuova formula che non sempre va a pari passo col mondo dell’architettura per come lo intendevamo.

Una casa in cui legno è sinonimo di innovazione
Esiste un parquet pregiato e avvolgente, caldo e raffinato, ma anche facile da posare e sostenibile? La risposta viene da Garbelotto.