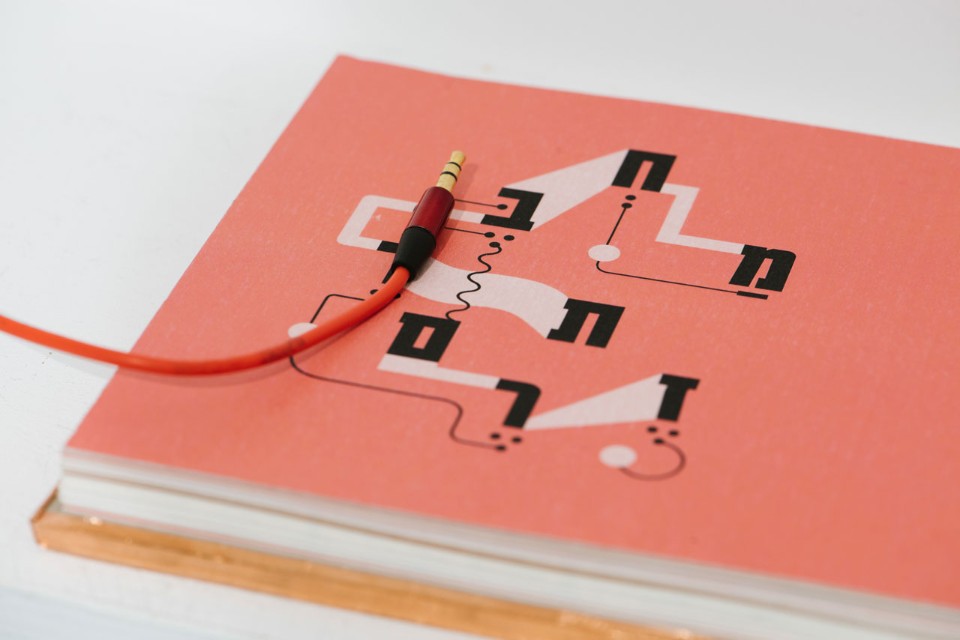Che dire di Gerusalemme, una città rivendicata da sempre da culture diverse, crogiolo di tradizioni, storie, leggende, religioni e persone? Questo melting pot unico al mondo, simbolo per eccellenza di ciò che dovrebbe essere chiamata integrazione (ma che difficilmente si può considerare realmente tale), non poteva che presentare una Design Week ricca, anzi ricchissima, di progetti, realtà, avventure e sogni con un unico comune denominatore: guardare al futuro grazie al filtro magico del design, strumento in grado di trasformare e migliorare la nostra società. Un auspicio necessario.
La terza edizione della Jerusalem Design Week è una babilonia d’informazioni, immagini, racconti, performance difficili da condensare in poche battute. Il lavoro magistrale operato dai due curatori Anat Safran e Tal Erez (entrambi con un cv d’eccezione alle spalle, una straordinaria passione e altrettanto talento) è tanto più apprezzato quando appunto impossibile da sintetizzare. La loro mostra principale “The Human Conservation Project” parla dello sforzo dell’essere umano nel preservare se stesso, sia a livello biologico sia culturale, toccando grandi temi quali la politica, la storia e la società in cui viviamo, con un focus specifico sul particolare contesto geografico.

 Galleria
Galleria
Come accade nella mostra “Flag” di Shy Ben Ari e Zohar Dvir, felice indagine sul tema della bandiera, oggetto capace di trasmettere in un battibaleno un messaggio univoco chiaro grazie a una serie di codici precisi e preesistenti che accomunano culture, luoghi e realtà. È in grado di incarnare storia e sogno quella nazionale bianca e azzurra, adottata il 28 ottobre del 1948 (ispirata allo scialle rituale – tallit o talled – con al centro la stella di David, disegnata per il movimento sionista nel 1891), espediente narrativo con cui più autori si interrogano sull’attuale situazione dello stato fondato sette decadi fa. Si tratta di un primo esempio per tracciare la molteplicità di voci orchestrata da Safran ed Erez che ben restituisce la pluralità di opinioni e visioni qui interpretate dai oltre 100 designer locali e internazionali invitati a farne parte, tutti chiamati a misurarsi con occhi diversi su temi quali il nostro imprescindibile bagaglio culturale, cosa conservare e cosa dimenticare di quest’ultimo, per capire oggi chi siamo, ma soprattutto chi saremo domani. Cosa tenere, mantenere del passato per migliorare il nostro futuro. Concetti dal notevole peso specifico, tra cui la vecchiaia (100 Years Old di Tali Kushnir e Alexandre Humbert), la menomazione fisica (The Alternative Limb Project di Sophie de Oliveira Barata), si esprimono grazie a diverse commissioni da parte dei curatori.

 Galleria
Galleria
Il titolo o tema dell’edizione è “Conservation”. Preservare, mantenere, migliorare il nostro mondo, quindi noi stessi. Istituita dal Ministry of Jerusalem and Heritage e dal Jerusalem Development Authority, voluto dalla Hansen House e gestito da Ran Wolf e Chen Gazit della Ran Wolf Urban Planning e Project Management LTD (quindi soldi pubblici), questa settimana del design è stata capace di far confluire in Terra Santa (dal 7 al 14 giugno) addetti ai lavori, curiosi e appassionati del settore, perfino con 45 gradi all’ombra. Dislocata in diversi spazi fuori dalle mura della città vecchia, tra cui il Bezek Building, Alliance House (sede di “Flag”), regna sovrano l’edificio della Hansen House. Prima lebbrosario poi manicomio, questo ampio complesso del XIX secolo che si sviluppa su più piani ed è costruito nella tradizionale pietra di Gerusalemme, è oggi sede principale della manifestazione e del Hansen House Center for Design, Media and Technology. Varcata la soglia, ci accoglie “Pro Jerusalem – 100 Years of Preservation”, mostra, curata da Alexandra Topaz, Hadar Porat, Keren Kinberg, che racconta come in questa città già dal 1918 si sia cercato di istituire delle regole generali basilari per preservare la sua integrità (architettonica e archeologica, non religiosa) da parte della Pro-Jerusalem Society (PJS), associazione fondata dall’allora governatore britannico di Gerusalemme Sir Ronald Henry Amherst Storrs. Un manifesto dalle norme precise codificava cosa era possibile fare e cosa no, come si poteva promuovere e migliorare la viabilità e l’estetica, e soprattutto un monito a non distruggere e al tempo stesso non costruire nulla su questo fazzoletto di terra. Marketing territoriale si direbbe oggi. Si legifera su tutto ciò che deve e può accadere dentro le mura fortificate, dalle insegne delle strade in porcellana all’urbanistica. Una serie di oggetti di uso comune sintetizza l’immaginario di un luogo dall’energia potente e coinvolgente; oggetti di ogni giorno dalla difforme tipologia – da cartoline turistiche glitterate, esemplari della pietra locale, posaceneri, giudaica di diversa fattura e provenienza fino a mosaici in piastrella a celebrare i primi 100 anni dall’istituzione di quell’associazione artefice dell’immagine di JSL così come la vediamo oggi.

 Galleria
Galleria
Il presente guarda al passato con gli occhi del futuro, anche se per qualcuno esiste già la certezza che il domani sarà esattamente come ieri. Negli ampi spazi del Jerusalem Theater poco distante, la mostra “Haredi-made: The Product on Orthodox Society” sull’universo misterioso e nascosto degli Haredi (ebrei ultraortodossi) presenta una serie d’interpretazioni da parte di membri della comunità (già un dato interessante) su usi e costumi, nonché regole (tante, tantissime) che determinano la vita quotidiana di questi religiosi; da una serie di teste porta-parrucca che assomigliano a statue (quasi rivoluzionarie in questa rigida e intransigente tradizione) fino a un trolley nero, ovviamente con ruote, per portarsi la Torah anche in viaggio. La mostra curata da Noa Lea Cohn, osservante oltre che cuore pulsante della Hamiklat Gallery for Contemporary Haredi Art, racconta un mondo lontano precluso all’integrazione e all’apertura verso una certa tipologia di più spicciola contemporaneità, ma non per questo privo di fascino. Anzi. Proseguendo nell’esplorazione degli spazi espositivi troviamo anche una Piazza della Rivoluzione, la cui direzione artistica delle belle performance che spaziano da una sfrenata danza di gruppo al taglio di capelli espresso, è affidata a Tal Gur. In questa piazza fatta di persone e momenti, tutti hanno la possibilità di esprimersi liberamente, senza regole.

 Galleria
Galleria
Oltre a collaborazioni con i due pilastri della didattica locale quali la Shenkar School of Engineering & Design (“Gaon’s Salon” è una serie di talk curata da Galit Gaon) e la Bezalel Academy (da non perdere la mostra degli studenti di Maya Dvash), Anat Safran e Tal Erez sono riusciti anche a costruire una rete di partnership internazionali con istituzioni, musei e fondazioni quali la Istanbul Design Biennale, il Polish Institute, D-Day Paris e la presenza italiana del Milano Design Film Festival.