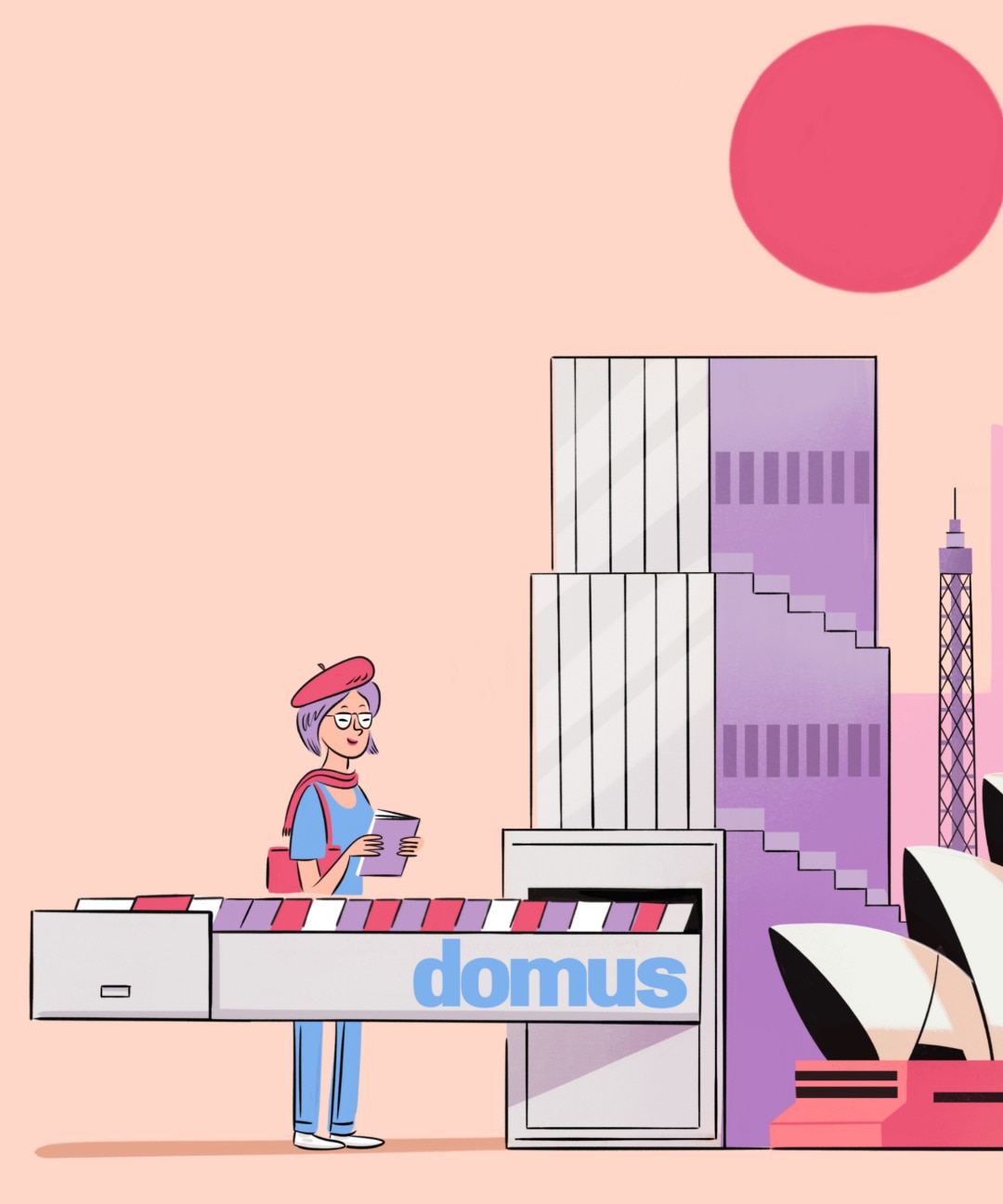Il passaggio di millennio, più precisamente l’arrivo del 2000, lo ricordiamo per tante ragioni, ma l’idea di una rivoluzione digitale, di un’era internet dalle grandi promesse, e di una pervasività dei computer in tutti gli aspetti di vita e lavoro ha sicuramente occupato gran parte del dibattito culturale, 25 anni fa, tra deliri collettivi come il millennium bug e ripensamenti concreti di spazi e pratiche. “Quali sono gli strumenti della creatività dei grandi progettisti oggi?”, si chiedeva Domus, nel numero 821, l’ultimo del 1999. “Sopravvivono quelli più tradizionali o sono stati invece soppiantati dai loro agguerriti eredi elettronici?”. Oltre che in un saggio di Daniele Del Giudice, la risposta veniva cercata nelle fotografie di Ramak Fazel – conoscenza Domus di lunga data, che ci ha accompagnat quest’anno in esplorazione della Rai di Gio Ponti a Milano – i ritratti di otto maestri italiani del design e dell’architettura, incontrati nel loro spazio di lavoro, parte di un più vasto reportage. Sottsass, Magistretti, Mangiarotti, Riva, Mari, Zanuso, Bellini, Castiglioni, le loro persone di fiducia e i loro studi milanesi; gli archivi, le dispense, i tavoli di designer “nati ‘con la penna in mano’ e trovatisi, gradualmente ma inesorabilmente, a fare i conti con l’invasione dell’informatizzazione”.

Computer e creatività. Un omaggio ai grandi progettisti
Quali sono gli strumenti della creatività dei grandi progettisti oggi? Sopravvivono quelli più tradizionali o sono stati invece soppiantati dai loro agguerriti eredi elettronici? La risposta l’abbiamo affidata a un racconto molto personale di Daniele Del Giudice e agli otto ritratti di altrettanti importanti architetti e designer milanesi colti da Ramak Fazel nell’intimità del luogo di lavoro, solo una selezione che fa parte di un più vasto reportage personale del fotografo. Una sorta di omaggio a questi maestri del design nati “con la penna in mano” e trovatisi, gradualmente ma inesorabilmente, a fare i conti con l’invasione dell’informatizzazione.

Foglio, matita, righello. Normografo, curvilinei, pastelli. Squadra, carta e matita. Vecchia Olivetti e fogli extrastrong, potrei dire nel caso di altre forme espressive. Per me non fu una Olivetti, ma una più antiquata Underwood, modello Altare della Patria o Milite Ignoto; la scovai in cantina quando avevo undici anni, e già pulirla, oliarla, serrarne le viti e rimetterla in funzione risultò più coinvolgente del Meccano. Al pomeriggio mi mettevo gli elenchi telefonici sotto il sedere per arrivare alla tastiera, e la scrittura era lì, era la macchina stessa, macchina per raccontare, macchina che da sola faceva i racconti che facevo io a voce ai compagni di gioco, storie vere o storie inventate, tormentandoli. I fogli senza linee per incanalare la scrittura a mano indicavano che quel tipo di carta non aveva nulla a che vedere coi quaderni, nulla a che fare con la scuola. La macchina possedeva i caratteri a stampa, quanto meno a pressione; era la stampa a portata di mano, quel che scriveva la macchina risultava stampato, cioè oggettivo, come oggettivi poiché stampati risultavano per me i romanzi e i racconti che leggevo. Anni dopo cambiai la vecchia e monumentale Underwood con un’altrettanto vecchia Royal americana, piccolissima e leggera, portatile dentro il suo astuccio nero e rigido. Talmente portatile che l’ho portata con me per decenni, ovunque e sempre, anche quando ero certo che non l’avrei usata. Era il mio pezzo di ferro, il mio strumento; se avevo uno strumento voleva dire che avevo anch’io un ‘lavoro’, o qualcosa che potessi pensare, al pari degli altri, “il mio lavoro”. Unico guaio, non potevo estrarla dall’astuccio come un violino e improvvisare qualcosa lì per lì, come un suonatore ambulante all’osteria, e poi girare per i tavoli con la custodia della Royal chiedendo monetine o banconote.

Abbandonare la macchina da scrivere per il primo computer fu perciò una decisione stupidamente procrastinata, ridicolmente sofferta, e infine sanamente liberatoria. Ognuno ha le proprie ritualità per cavare da sé il meglio o il poco che può offrire in dono; e se qualcuno mi avesse chiesto cosa fosse il raccontare e la scrittura avrei esordito col mostrare, anche in età matura, come si pulisce la macchina da scrivere, con un ago capovolto per togliere l’impasto di nastro consumato dalle cavità delle lettere senza danneggiare il piombo dei rilievi. Fui molto confortato, anni dopo ancora, quando seppi che Carlo Scarpa cominciava i suoi corsi di architettura all’Università illustrando il modo migliore per fare la punta alle matite.

I motivi per cui all’inizio diffidavo del computer erano opposti a quelli per cui da ragazzino mi ero abbandonato e fuso con la macchina da scrivere: se allora lo stampato della macchina dava l’idea di un qualcosa fatto davvero, adesso il perfetto stampato del computer, impaginato e definitivo e simil-libro, insomma la “perfezione estetica” di quel che vedevo nel monitor mi lasciava assai poco convinto e diffidente dei contenuti. Li eccedeva. Ci volle poco, però, per capire che computer e scrittura hanno un legame di radice profonda, sono fatti uno per l’altra. Anzi, “sono fatti uno dell’altra”: usiamo un linguaggio macchina, codice alfanumerico, alfabeto per noi totalmente privo di senso comune, per comporre alfabeti e testi in forma di senso comune. E “homepage”, il termine inglese dei siti in Rete, dice bene, e dice fin dall’inizio, come il cyberspazio sia fatto semplicemente di scrittura e lettura velocissime nel tempo reale dei millisecondi, comprensibilmente articolate dunque in pagine casa. La casa pagina è fabbricata con blocchi di testo HTML, anche le icone e le immagini e i disegni sono fatti di codice alfanumerico, lettere; sequenze di caratteri sono i suoi piani, le stanze, il mobilio e tutto ciò che la casa contiene.

È naturale che i nuovi oggetti, soprattutto quelli che incidono nella carne e nei modi del nostro lavoro, ci lascino ogni volta fortemente convinti o fortemente perplessi. Si tratta di oggetti, niente di più, come lo erano la squadra o la vecchia Olivetti, ma nella loro natura di oggetti racchiudono alcune domande, almeno due: da dove comincia il lavoro? come cambia il lavoro? Si presentano ‘friendly’ all’aspetto, alleviano fatiche o abbreviano tempi o rendono possibile ciò che prima non era, ma così facendo spostano la soglia da cui procede l’essenza di quel che chiamiamo ‘elaborazione’ o ‘invenzione’. E se risolvono molto, chiedono ancora di più. Come è sempre accaduto.