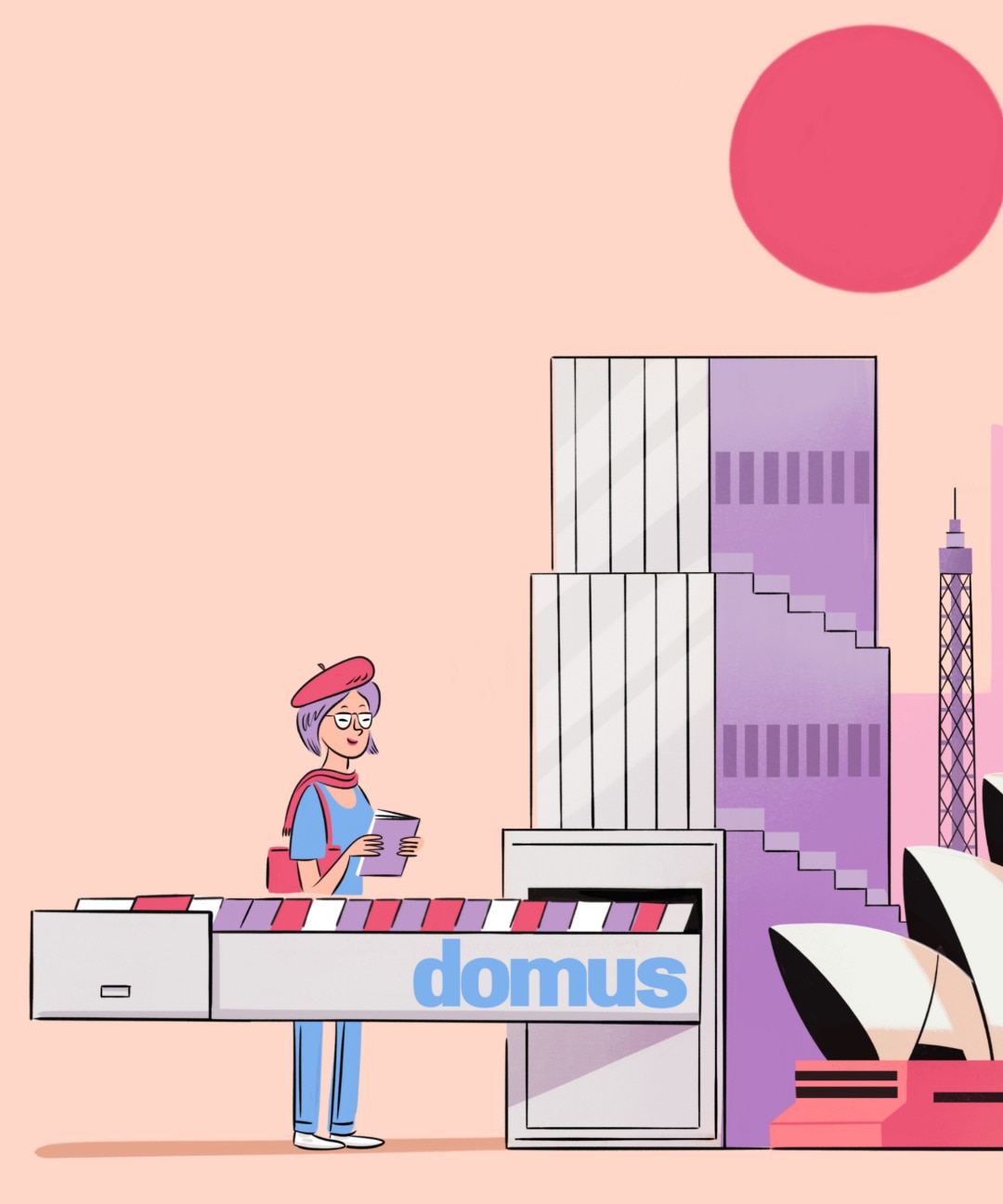L’energia del domani nasce dalle idee di oggi
Enel lancia un contest internazionale “WinDesign” per immaginare il nuovo design delle turbine eoliche.
I volumi a sbalzo sono nell’architettura un sinonimo di sfida strutturale e progettuale. Se da un lato gli elementi in aggetto rimandano alle conquiste tecniche dell’800, non possono che tornare alla mente i progetti visionari del novecento, dai costruttivisti russi, come El Lissitzky, in cui piastre a più piani rimanevano sospese a sbalzo su pilastri urbani. O ancora, le opere visionarie del metabolismo giapponese, o i piani a sbalzo de la Casa sulla Cascata di F. L. Wright.
Oltre l’utopia e i progetti antesignani del primo ‘900, il panorama progettuale offre numerosi esempi di architetture che hanno guardato all’aggetto dei volumi per la loro espressività. Abbiamo quindi raccolto 15 architetture, che in varie parti del mondo, con estetiche, materiali e funzionalità differenti, riescono ad esprimere un mosaico variegato di questa tema progettuale. Nei progetti, la tensione tra leggerezza e contrasto alla gravità, poesia e forza tecnica, diventano il cuore pulsante dello spazio, ed esprimono l’essenza di queste architetture.
I progetti raccolti intessono un racconto internazionale: dallo sperimentalismo nordeuropeo, alla poetica della costruzione sudamericana, fino alle sceniche architetture negli emirati. Si inizia dagli anni Sessanta, con alcune architetture brutaliste come l’Aula di Borek Bakema a Delft, dove corpo dell’architettura si eleva, con le nervature, i pilastri e le travi in cemento armato, che diventano cifra linguistica dell’opera stessa, che si ritrova anche nella Geisel Library di William Pereira.
Passando dagli Mvrdv con il celebre WoZoCo e i suoi volumi aggettanti, si approda poi ai primi anni 2000. Se con Coop Himmelb(l)au l’edificio diventa un corpo sospeso, con il VitraHaus i singoli elementi che lo compongono si sovrappongono liberamente producendo aggetti e spazi inattesi.
Da qui, alcune architetture dalle dimensioni più ridotte, come quelle di Pezo Von Ellrichshausen o Irrazzaval, mostrano come anche alla scala domestica l’aggetto possa diventare perno per una potenza espressiva e costruttiva. Infine, a concludere la raccolta, alcune grandi opere recenti come lo Shenzhen Stock Exchange o l’One Za’abeel, che nella semplicità dei volumi disegnano nuovi landmark delle metropoli contemporanee.

1. Aula TU Delft – Broek Bakema (1966)
Costruita tra il 1959 e il 1966, l’Aula è uno dei simboli della celebre università olandese di Delft. Disegnata dallo studio Broek Bakema, noto per le opere del dopoguerra a Rotterdam, il progetto assume una forma plastica e dall’estetica brutalista.
L’architettura in cemento armato si poggia al terreno, dal quale il volume si solleva e aggetta sul fronte principale e verso il retro. Simile ad un’astronave, l’ingresso è coperto dal grande aggetto che ospita al suo interno l’auditorium dell’università. Il vassoio in cemento armato vede quindi uno sbalzo di 15 metri, sorretto da pilastri in cemento armato a pianta triangolare, che, come nervature, irradiano il volume. Nella porzione opposta dell’edificio, sono invece alcune aule di dimensioni minori ad aggettare verso l’esterno, concludendo il volume.
Broek Bakema, Aula TU Delft, Delft, 1966. Foto Gerard Dukker, via Wikimedia.

1. Aula TU Delft – Broek Bakema (1966)
Broek Bakema, Aula TU Delft, Delft, 1966. Foto Thea van den Heuvel, via Wikimedia.

2. Geisel Library – William Pereira (1968)
A metà tra un edificio brutalista e un disegno sperimentale del futurismo, la Geisel Library di William Pereira troneggia all’interno dell’università della California a San Diego.
L’edificio di 8 piani vede la sequenza di livelli sovrapporsi e accrescere di dimensione. Se la pianta ricorda un impianto cruciforme, al cui centro sono raccolti i sistemi di risalita e i servizi, in sezione l’edificio ricorda lo sviluppo di un albero. A sottolineare la similitudine sono anche i pilastri esterni all’edificio, che definiscono un portico al piano terra, e sorreggono inclinati lo sbalzo crescente dei piani dei primi piani.
Un’architettura di vetro e cemento armato, dove la struttura portante si radica come un esoscheletro al contesto, mentre i piani vetrati riempiono con leggerezza lo spazio.
William Pereira, Geisel Library, San Diego, 1968. Foto Ben Lunsford, via Wikimedia.

2. Geisel Library – William Pereira (1968)
William Pereira, Geisel Library, San Diego, 1968. Foto Tamas, via Adobe Stock.

3. WoZoCo – Mvrdv (1997)
Le residenze WoZoCo sono diventate un emblema dello sperimentalismo nordico, che caratterizza da ormai trent’anni lo studio Mvrdv. In questo progetto, non solo la residenza si arricchisce di colori variopinti, a disegnare facciate multicolore, ma l’aggetto diventa il tema centrale dell’architettura. Come volumi autonomi, alcuni piani vedono interi appartamenti aggettare, creando sbalzi così marcati che sfidano la logica della costruzione. . Delle travi a parete riescono infatti a incastrare nel corpo principale degli elementi in aggetto, dalla profondità similare a quella dell’edificio principale stesso. A sottolineare questa invenzione della forma, gli aggetti sono rivestiti in legno su tutte le facciate, in contrasto con la vetrata continua da cui sbalzano..
Mvrdv, WoZoCo, Amsterdam, 1997. Foto Rob't Hart.

3. WoZoCo – Mvrdv (1997)
Mvrdv, WoZoCo, Amsterdam, 1997. Foto Rob't Hart.

4. Busan Cinema Center / Pusan International Film Festival – Coop Himmelb(l)au (2008)
Come descritto dai progettisti, il Busan Cinema Center è un’architettura che diventa intersezione tra spazio pubblico, spazio culturale, di svago, e tecnologia, generando un landmark per la città sudcoreana. A caratterizzare questo intervento è senza dubbio il grande volume aggettante, che diventa una grande copertura ondulata per una piazza coperta. Qui la superficie ondulata è ricoperta da LED che trasformano la superficie in un maxischermo pubblico e iconografico, il quale ospita infatti illuminazioni artistiche.
All’interno di questi volumi troviamo una struttura reticolare che lascia spazio ad aree comuni, assolvendo inoltre alla distribuzione orizzontale e verticale tra i corpi del complesso.
Coop Himmelb(l)au, Busan Cinema Center, Busan, 2008. Foto © Duccio Malagamba.

4. Busan Cinema Center / Pusan International Film Festival – Coop Himmelb(l)au (2008)
Coop Himmelb(l)au, Busan Cinema Center, Busan, 2008. Foto © Duccio Malagamba.

5. VitraHaus – Herzog & de Meuron (2009)
Caratterizzato da una sovrapposizione di volumi, la cui sezione richiama l’archetipo di una casa, il VitraHaus si inserisce nel Vitra Campus a Weil am Rhein. Il progetto ospita al suo interno l’esposizione dell’azienda Vitra, sviluppandosi quindi su 5 livelli. I volumi sono così giustapposti in modo da creare delle gallerie percorribili in cui la distribuzione verticale si risolve nei punti di contatto e intersezione dei vari corpi.
La sovrapposizione e rotazione degli stessi genera così uno spazio espressivo e dinamico, nel quale la sequenza di aggetti costruisce uno schema permeabile. Si risolve in questo modo un’idea primigenia dell’abitare, che viene però giocata nella composizione, in un’apertura verso il paesaggio, che genera un progetto articolato e contemporaneo.
Herzog & de Meuron, VitraHaus, Weil am Rhein, 2009. Foto Taxiarchos228, via Wikimedia.

5. VitraHaus – Herzog & de Meuron (2009)
Herzog & de Meuron, VitraHaus, Weil am Rhein, 2009. Foto Taxiarchos228, via Wikimedia.

6. Balancing barn – Mvrdv (2010)
L'edificio è costruito nella campagna inglese del Suffolk, la Balancing barn riprende le forme tipiche e semplici del fienile, utilizzando poi un rivestimento in lamiera riflettente attraverso cui si gioca il carattere contemporaneo dell’architettura.
L’opera, lunga 30 metri, vede la metà della stessa sospesa in aggetto rispetto ad un declivio importante del terreno. Il volume rimane così sospeso a mezz’aria, al limite di un gioco manierista di equilibrio. A sottolineare quest’idea, al fronte sospeso è agganciata una piccola altalena, il cui movimento richiama un dinamismo celato dall’architettura stessa.
La realizzazione dell’opera è stata permessa grazie all’utilizzo di un nucleo centrale in cemento armato, ancorato al suolo, e dalla presenza di materiali leggeri per lo sbalzo e pesanti per la restante.
Mvrdv, Balancing Barn, Suffolk, 2010. Foto © Edmund Sumner.

6. Balancing barn – Mvrdv (2010)
Mvrdv, Balancing Barn, Suffolk, 2010. Foto © Edmund Sumner.

7. The View Hill House – Corker Marshall (2011)
Sulla sommità di una collina, il progetto della The View Hill House torreggia sul paesaggio australiano. Le forme semplici si compongono di due parallelepipedi sovrapposti, rivestiti in lamiera metallica. Radicato al suolo abbiamo un volume in corten, sul quale è poggiato e in aggetto un volume rivestito con lastre in alluminio nero opaco. Lo sbalzo raggiunge rispettivamente i 6 e i 9 metri sui due fronti, sbilanciando la composizione in un equilibrio dinamico.
Entrambi i volumi presentano così grandi aperture sui lati corti, ponendosi in continuità visiva con il paesaggio rurale. Al contempo, l’architettura si staglia all’interno sulla linea dell’orizzonte, che nelle forme semplici vede nello sbalzo un segno di riconoscibilità.
Corker Marshall, The View Hill House, Yarra Valley, 2011. Foto Tim Griffith.

7. The View Hill House – Corker Marshall (2011)
Corker Marshall, The View Hill House, Yarra Valley, 2011. Foto Tim Griffith.

8. Caterpillar House – Sebastián Irarrázaval (2012)
Con Caterpillar House ci spostiamo nella periferia di Santiago de Chile. Qui la casa per un collezionista d’arte utilizza cinque container prefabbricati, come soluzione per ridurre costi e tempo di lavorazione, rendendo il loro riuso una forma poetica dello spazio. Dalla strada, alcuni volumi sono adagiati sul declivio, raggiungendo poi il corpo centrale della casa, dal quale, al secondo piano, fuoriescono tre importanti parallelepipedi poggiati su una trave metallica a segnare il limitare del corpo principale.
Il progetto sottolinea così la scansione in fasce dello spazio, nelle quali non solo è distribuito il programma dell’abitazione, ma diventa un metodo per aumentare la ventilazione naturale dello spazio. Dal carattere quasi industriale, la Caterpillar House di Sebastián Irarrázaval riesce nel portare l’aggetto alla scala domestica, in una composizione dinamica ma accogliente allo stesso tempo.
Sebastián Irarrázaval, Caterpillar House, Lo Barnechea, 2012. Foto Sergio Ricaroruga.

8. Caterpillar House – Sebastián Irarrázaval (2012)
Sebastián Irarrázaval, Caterpillar House, Lo Barnechea, 2012. Foto Sergio Ricaroruga.

9. Solo House Casa Pezo – Pezo Von Ellrichshausen (2012)
Un monolite in cemento armato e vetro rimane sospeso nel paesaggio. Attraverso un sentiero gradinato in cemento si raggiunge la base della Solo House, incontrando l’architettura attraverso l’angolo del basamento cieco. Si percepisce così il piano superiore, interamente aggettante rispetto al basamento, dando al progetto un carattere insieme primitivo e contemporaneo.
La semplicità delle forme e delle finiture lascia che la casa paia come un affioramento del terreno stesso, dove l’edificio rimane in equilibrio tra basamento e declivio naturale, una piattaforma abitata, che si contrappone alla solidità del piano terra, caratterizzandosi dalla successione di sedici colonne dalle dimensioni considerevoli disposte perimetralmente.
Al centro dell’abitazione, una corte con una piscina richiama l’architettura mediterranea, concludendo uno spazio quasi metafisico, in cui lo sbalzo diventa anch’esso un gesto simbolico di connessione con il cielo e il territorio.
Pezo Von Ellrichshausen, Solo House Casa Pezo, Teruel, 2012. Foto courtesy by Pezo Von Ellrichshausen.

9. Solo House Casa Pezo – Pezo Von Ellrichshausen (2012)
Pezo Von Ellrichshausen, Solo House Casa Pezo, Teruel, 2012. Foto courtesy by Pezo Von Ellrichshausen.

10. Nanjing Sifang Museum – Steven Holl (2013)
Costruito nel paesaggio verdeggiante di Pearl Spring, vicino a Nanjing, in Cina, il progetto di Steven Holl appare come un volume in policarbonato che si snoda nel cielo e tra la nebbia delle montagne. L’architettura, più di altri esempi di Holl, echeggia i dipinti ad acquerello dell’architetto. Lo sbalzo diventa in questo museo l’architettura stessa. Gli elementi di sostegno si confondono con i colori bruni del paesaggio, così come del volume adagiato al suolo, facendo così risaltare la disarticolazione sospesa. L’utilizzo del policarbonato, inoltre, alleggerisce visivamente l’opera, celando il fitto sistema di travi e pilastri in acciaio che si ancorano agli elementi portanti verticali.
Il museo appare così come l’accostamento di cielo, il volume sopraelevato, e terra, la sistemazione del suolo e il corpo dell’auditorium, arrivando quasi a trasformare l’architettura in una trasposizione costruita di un’opera concettuale.
Steven Holl, Nanjing Sifang Museum, Nanjing, 2013. Foto © Sifang Art Museum.

10. Nanjing Sifang Museum – Steven Holl (2013)
Steven Holl, Nanjing Sifang Museum, Nanjing, 2013. Foto © Sifang Art Museum.

11. Villa Méditerranée – Stefano Boeri architetti (2013)
Villa Méditerranée, costruita lungo il limite del porto di Marsiglia, vede un volume unitario, modellato a creare uno sbalzo di 36 metri.
Verso il mare, l’architettura ha un trattamento quasi modernista della facciata. Scandita da lastre in cemento armato, in cui il rigore di finestre a nastro e aperture più grandi descrive l’intero sistema. Come una fascia continua, il sistema avvolge il volume, lasciando che lo sbalzo pieghi la logica geometrica, trasformando così una porzione di facciata nella finitura inferiore dello sbalzo. Lateralmente, invece, il museo si apre interamente tramite un sistema vetrato, che scandisce così l’intero volume.
Al di sotto del monumentale sbalzo, una pizza d’acqua caratterizza lo spazio aperto, concludendo l’opera stessa in uno spazio aperto ma coperto, tra il mare e la costa.
Stefano Boeri architetti, Villa Méditerranée, Marsiglia, 2013. Foto Su Haowei/Wirestock Creators, via Adobe Stock.

11. Villa Méditerranée – Stefano Boeri architetti (2013)
Stefano Boeri architetti, Villa Méditerranée, Marsiglia, 2013. Foto Rémih, via Wikimedia.

12. Villa Kogelhof – Paul de Ruiter Architects (2013)
Costruita nei Paesi Bassi, la Villa Kogelhof disegna un orizzonte sospeso nella campagna olandese. Un parallelepipedo puro, in cui due solette orizzontali in cemento armato contengono uno spazio fluido, la cui trasparenza è garantita da un nastro vetrato continuo su tutti i lati.
Quasi Miesiano, il progetto, che ridisegna anche lo spazio esterno secondo fasce vegetate e coltivate, sopralza lo spazio della casa, che rimane così sospeso. La villa si posa così su due elementi: un volume traslucido di accesso, nel quale sono contenute le scale, e due pilastri a V, che affondano nel terreno.
Infine, uno specchio d’acqua, trasversale alla casa, conclude la geometria esatta dello spazio tra paesaggio e architettura, al di sotto del quale è stato ricavato lo spazio per il box auto e deposito. La casa rimane così nella sua purezza formale, un oggetto sospeso nell’orizzonte piatto della campagna.
Paul de Ruiter Architects, Villa Kogelhof, Noord-Beveland, 2013. Foto Peter Buteijn.

12. Villa Kogelhof – Paul de Ruiter Architects (2013)
Paul de Ruiter Architects, Villa Kogelhof, Noord-Beveland, 2013. Foto Jeroen Musch.

13. Shenzhen Stock Exchange – Oma (2013)
Se lo sbalzo del CCTV Headquarters a Pechino ha segnato a inizio 2000 una delle opere visionarie dello studio Oma, con occhi simili si potrebbe guardare allo Shenzhen Stock Exchange. Seppur dalle forme più regolari, l’edificio presenta un grattacielo imponente, il cui basamento, solitamente radicato al suolo, viene invece sollevato, generando un volume a sbalzo. Quasi come fosse un edificio autonomo, lo sbalzo presenta poi un tetto giardino che disegna un nuovo suolo, un paesaggio artificiale dal quale si erge poi il grattacielo. Se quest’ultimo è caratterizzato da una facciata semplice, in cui la ripetizione di un modulo quadrato diventa la soluzione compositiva, per il volume aggettante il sistema è variato. Qui, delle travi reticolari di dimensione gigante corrono sulla facciata e nella porzione basamentale del grattacielo, mostrando la forza strutturale connessa alla presenza del grande sbalzo.
Oma, Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen, 2013. Foto Jay Sterling Austin, via Wikimedia.

14. La Maison du Savoir, University of Luxembourg – Baumschlager Eberle Architekten (2015)
Il progetto, nato per creare un nuovo fulcro per l’Università del Lussemburgo, ha voluto disegnare un landmark per la città. Le sue forme, semplici, vedono l’intersezione di due volumi: una lama in altezza, che raggiunge gli 85 metri, e un lungo parallelepipedo a generare una sequenza di spazi aperti ma coperti. Qui l’aggetto determina una sospensione del volume, nonché la possibilità di generare uno spazio dinamico e iconico insieme. La sua realizzazione è stata possibile grazie all’utilizzo di solai in cemento armato precompresso, che hanno garantito la possibilità di avere ampie superfici a sbalzo. La facciata, invece, viene risolta con un sistema che avvolge entrambi i corpi descritti, dando uniformità e permeabilità all’architettura.
Baumschlager Eberle Architekten, La Maison du Savoir, University of Luxembourg, Luxembourg, 2015. Foto Eduard Hueber.

14. La Maison du Savoir, University of Luxembourg – Baumschlager Eberle Architekten (2015)
Baumschlager Eberle Architekten, La Maison du Savoir, University of Luxembourg, Luxembourg, 2015. Foto Eduard Hueber.

15. One Za’abeel – Nikken Sekkei (2023)
Dubai è certamente uno dei luoghi in cui i landmark si sono via via sovrapposti e accumulati. Ne è esempio il progetto recentemente concluso a firma di Nikken Sekkei, che ha progettato due grattacieli connessi da un sottile volume che pare incastrato in un timido bilanciamento tra le due torri. Il tema di questa connessione in altezza, che ha dato vita ad un’architettura in cui lo sbalzo diventa l’elemento di riconoscibilità del progetto stesso, deriva non solo da una volontà linguistica, ma anche da una necessità urbana. Infatti, il lotto nel quale sorgono le due torri vede un’arteria stradale tagliarlo a metà. Generando così uno spazio a terra frammentato e diviso. Per ovviare al problema, lo studio sviluppa cosi un ponte in altezza, che riunisce l’architettura, oltre ad aiutare la stabilità delle due torri rispetto le correnti del vento.
Nikken Sekkei, One Za’abeel, Dubai, 2023. Foto ©Hufton+Crow.

15. One Za’abeel – Nikken Sekkei (2023)
Nikken Sekkei, One Za’abeel, Dubai, 2023. Foto ©Hufton+Crow.

L'ultima collezione di Ethimo è una questione di intrecci
Ispirata alle lavorazioni tipiche della spagna orientali e ai patios, la nuova collezione disegnata da Studio Zanellato/Bortotto ripensa l'estetica del comfort.