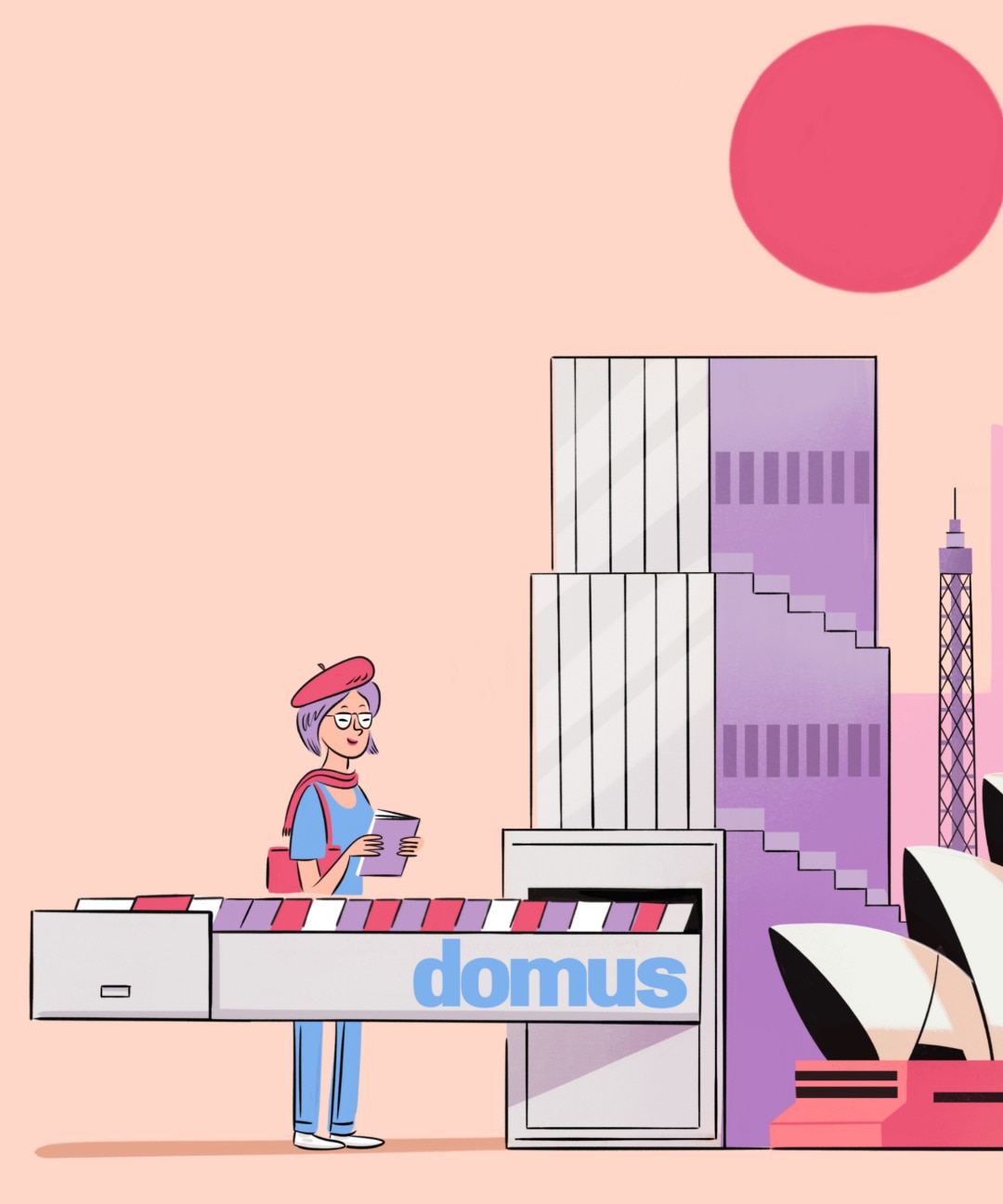Tra il 1960 e il 1980 Alberto Salvati ed Ambrogio Tresoldi hanno animato la scena culturale milanese portando al centro della loro ricerca la confluenza tra arte e architettura. Noti per l’uso del colore, elemento caratterizzante della loro opera, i loro progetti venivano sistematicamente pubblicati su Domus quando il direttore era Gio Ponti, che già dai primi anni Trenta aveva promosso sulla rivista il principio dell’interdisciplinarità, suggerendo la collaborazione tra architetti, artisti, artigiani e industrie dell’arte. Ponti, che rimarrà direttore di Domus fino all’anno della sua morte (1979), aveva compreso la forza progettuale del lavoro di questi due architetti, frutto della loro ricerca sull’evoluzione della cellula abitativa.
Il pensiero progettuale di Salvati e Tresoldi nasce infatti dalla critica all’idea di cellula abitativa dell’architettura moderna. Laureati nel 1960, i due avevano studiato al Politecnico di Milano con Carlo De Carli, promotore del concetto di spazio primario, ovvero lo spazio fondamentale per l’individuo per vivere. La loro ricerca nasce dalla confutazione dei principi del movimento razionalista e, in particolare, della macchina per l’abitare di Le Corbusier. Da tali principi Salvati e Tresoldi hanno iniziato a pensare ad una nuova concezione dell’architettura, che supera i limiti funzionalisti del razionalismo verso l’inclusione dell’immaterialità degli aspetti spirituali nella progettazione architettonica. Gli spazi interni che disegnavano erano spazi di libertà, non spazi rifugio, né macchine, né antri, ma palcoscenici aperti allo spettacolo del vivere quotidiano. Abbiamo incontrato l’architetto Salvati, dopo più di cinquant’anni, per fargli delle domande, mai fatte prima, sul loro lavoro.

Quali progetti e quali temi portavate sulla rivista?
Quelli che presentavamo su Domus erano, prevalentemente, progetti per il ceto medio-alto ma le nostre ricerche avevano come obbiettivo quello di ripensare gli spazi dell’edilizia popolare. In quegli anni a Lissone si tenevano a cadenza biennale le Settimane Lissonesi, sette giorni in cui la città diventava un museo a cielo aperto e venivano esposti oggetti di design e arredamento. Nel 1961, subito dopo la laurea, siamo stati incaricati del coordinamento della Settimana Lissonese per la casa. Poi, a scadenza biennale, in concomitanza con il Premio Lissone d’arte, il nostro impegno con l’ente comunale del mobile di Lissone era proseguito fino agli anni Settanta. Il nostro interesse per le problematiche relative allo spazio interno in architettura aveva portato nel frattempo a pubblicare una ricerca sui centri mobilieri italiani e la loro possibilità di interferire con quanto si andava producendo in ambito architettonico, insieme a un altro gruppo di progettisti di cui faceva parte anche Renzo Piano. Si discuteva di come i centri mobilieri potessero creare dispositivi di arredamento che si integrassero con lo spazio dell’abitare. Così abbiamo iniziato a lavorare a progetti in cui i mobili si integravano con lo spazio, questo era uno dei temi più discussi su Domus e di cui Gio Ponti era promotore. Questi studi poi sono stati realmente applicati in contesti popolari, quando abbiamo realizzato due complessi per l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).
Il tema dell’edilizia pubblica è stato centrale nel vostro lavoro.
Sì, nel 1973 questi esperimenti condotti insieme alla facoltà di Architettura sono stati portati in Triennale, a Milano, quando abbiamo coordinato ed allestito la mostra Spazio abitativo nell’edilizia pubblica per la XV edizione presso il Palazzo dell’Arte. In mostra abbiamo presentato alcuni esempi di come l’utilizzo di elementi diversi rispetto a quelli della disciplina architettonica giovassero ai suoi utenti, ovvero l’uso del colore e la collaborazione con gli artisti. Il nostro era un modo di operare paritetico dove tutte le discipline avevano pari importanza nel progetto, siamo partiti dalla vecchia sintesi di integrazione delle arti e l’abbiamo interpretata secondo la nostra maniera al fine di realizzare un progetto che fosse un insieme unitario in cui confluivano i vari saperi. Gio Ponti era venuto a vedere la mostra, interessato ai progetti realizzati per il rinnovamento dell’habitat secondo quanto andavamo producendo insieme agli artisti, all’uso del colore come materiale di costruzione e alle relative trasformazioni planimetriche che ne derivavano. Discorso che è rimasto centrale in Domus fino agli anni Ottanta.

Il colore era un elemento caratterizzante del vostro lavoro. Era voluto? Se sì, perché?
Nel 1919, quando si stavano delineando i principi del Movimento Moderno, su una rivista tedesca era uscito un articolo dal titolo Un invito all’architettura colorata, firmato da Gropius, Beherens, Taut e altri. In questo articolo si parlava del problema del colore e di come utilizzarlo nei progetti di architettura moderna. Pochi anni dopo, nel 1928, Piero Bottoni aveva pubblicato, sempre su una rivista tedesca, un articolo dal titolo Cromatismi architettonici inerente al tema. Dopo avere studiato questi testi abbiamo iniziato a riflettere sull’uso del colore nella nostra pratica e nel tempo è diventato il nostro elemento caratterizzante. Per noi, infatti, il colore era un elemento architettonico, che modificava e definiva lo spazio. Alberto Sartoris, nel volume dedicato alla nostra opera pubblicato nel 1980 da Electa, scriveva: “le armonie spesso vellutate di Salvati e Tresoldi esaltano il nero, il rosso, il blu e l’ocra, il giallo, il bruno e il verde, il marrone, il bianco e il beige, il grigio, il bistro e il viola, tanto nelle loro implicazioni e intrecci orizzontali che verticali. Colori vivaci e lucenti, dai disegni zigzaganti alla Max Bill, in catene incrociate, a zebrature bianche e nere, alternati in forme a schermi scavati dal sole e dalla luce […]” (pubblicato anche su Domus, n. 653, settembre 1984, p. 30, NdR).
Nei vostri progetti di quel periodo si nota una certa confluenza tra l’architettura e le tendenze estetiche delle arti visive. A quale arte facevate riferimento?
Non ci riferivamo ad una corrente artistica in particolare ma eravamo immersi nel clima di quegli anni e soprattutto collaboravamo con molti di loro. Nel 1968 avevamo organizzato una mostra nel nostro studio dal titolo Achromes dove avevano esposto, tra i tanti, anche Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Gianni Colombo, Lucio Fontana, Ugo La Pietra, Piero Manzoni, Paolo Scheggi, Tino Stefanoni e Tea Valle. Questo interesse per l’arte e per il colore ci aveva portato a lavorare spesso con gli artisti. Si pensi, per esempio, alla casa al mare le cui pareti sono state dipinte da Giuliano Barbanti, con cui abbiamo collaborato spesso (e pubblicata su Domus, n. 495, febbraio 1971, pp. 25-27, NdR). Gli artisti facevano una serie di operazioni all’interno dei nostri progetti che ne definivano lo spazio.
Esistono ancora i progetti da voi realizzati in quel periodo? Che rapporto avevate con i committenti?
Sì. La casa bifamiliare a Lissone, copertina della monografia di Electa del 1980, è perfettamente conservata. Quella casa è uno dei nostri lavori più interessanti, l’ingresso rompe la simmetria dell’edificio attraverso l’uso del colore e delle forme. (Domus, n. 615, marzo 1981, pp. 42-43). Anche la casa che abbiamo realizzato ad Arenzano nel 1978 è ancora intatta. I nostri committenti sono sempre stati parte di questo circolo di architetti, artisti e galleristi promotori dell’interdisciplinarità, quindi hanno sempre capito e apprezzato il nostro lavoro. Pensi che la figlia di un noto collezionista di Milano quando dovette ristrutturare la sua abitazione chiese di riprodurre lo stesso progetto di quando era bambina, mantenendo i colori e gli schemi relativi alla sua precedente esperienza abitativa. Credo che qui il colore assuma un tono quasi nostalgico, di casa come contenitore di ricordi infantili.

Besenzoni porta i riflessi del mare al Fuorisalone
Un’installazione per la Milano Design Week 2025 celebra l’esperienza del navigare tra mare aperto e luce, resa unica dal carattere innovativo della poltrona pilota Manta.