Quasi 500 pagine. Almeno una trentina di personaggi. E alcuni decenni di storia italiana – dalla fine della Grande Guerra alla caduta del fascismo – rievocati attraverso la vicenda collettiva di quel gruppo di architetti che proprio negli anni del regime sognarono di ammodernare e migliorare il paese, e forse anche di cambiare il mondo, attraverso l’architettura.
Venivano da tutta Italia (irredentisti istriani come Pagano, maestri comacini come Terragni, napoletani inquieti come Persico, insieme a tutti i figli del Politecnico, Figini, Pollini, Bottoni, Banfi, Belgiojoso, Peressutti, Rogers, e ancora Albini, Gardella, Zanuso…), ma si ritrovarono a Milano. La città che aveva ospitato l’esposizione universale del 1905 e dove era nato il futurismo. La città della Rinascente, della Triennale, di Domus e di Casabella. La città dinamica e moderna che guardava a Londra, Parigi e Berlino, senza celare un sussiegoso disprezzo nei confronti della politica centralistica romana.

Quello che noi non siamo (Guanda, 2023) di Gianni Biondillo racconta la loro avventura. E lo fa, coraggiosamente, in forma di romanzo. Dietro – lo si coglie a ogni pagina – c’è un lavoro di documentazione scrupoloso e impressionante, simile a quello compiuto da Antonio Scurati per il suo M. Il figlio del secolo. Lo riconosce lo stesso Biondillo: “Anni di studio, di libri accatastati, di biblioteche pubbliche e private consultate, di archivi compulsati, di lettere dal fronte decrittate. Non c’è praticamente nulla di inventato, è tutto documentato in modo rigoroso e quasi fanatico, comprese le parti relative alla vita privata dei protagonisti, al loro carattere, alle loro bizze e alle loro paure”.
Io non parlo di architettura in questo romanzo, io uso l’architettura per raccontare il Paese.
Gianni Biondillo

Perché allora non un lavoro accademico di alto profilo? La risposta di Biondillo – che pure è laureato in architettura, anche se da anni si dedica ormai soprattutto alla letteratura – è lucida e chiara: “Perché sarebbe stato l’ennesimo saggio che ci saremmo letti fra di noi dell’ambiente. Mentre una storia di tale fattura meritava di essere raccontata a tutti. Questa storia, nella sua complessità, non la conosceva praticamente nessuno. Neppure gli accademici. Se avessi parlato del rapporto fra intellettuali e potere, facendo i nomi di Montale, Calvino, Vittorini, tutti avrebbero capito immediatamente di cosa stavo parlando. Ma quando si parla di architetti, fuori dalla nostra cerchia, nessuno sa nulla. A malapena si conosce Terragni e si pensa che un Terragni e un Piacentini siano, analogamente, ‘architetti fascisti’. Nulla di più falso. Terragni, tra l’altro, odiava dal profondo del cuore Piacentini!”.
Pagina dopo pagina, con un respiro la cui ampiezza ricorda quella del romanzo storico di manzoniana memoria, Quello che noi non siamo (il titolo è un evidente allusione a un celebre verso di una poesia di Montale) immerge il lettore in una straordinaria avventura umana e intellettuale: quella di un gruppo di giovani architetti che in nome del razionalismo stavano trasformando Milano e Como in uno dei laboratori di modernità più avanzati nell’Europa delle avanguardie. Uno dei capitoli del libro finisce però con un’accusa molto forte: “Tutti assieme a lavare il volto del fascismo”. Il fascismo li ha usati? Ne erano affascinati? Inizialmente sì, vedevano anche nei grandi progetti del regime un segno di modernità. Ma ne furono anche complici?

“La loro – osserva Biondillo – fu una generazione, come ebbe a scrivere proprio Montale, ‘naturaliter fascista’. Quando Mussolini andò al potere Terragni aveva 18 anni, i Bbpr ancora meno, erano dei bambini. Quanto dal punto di vista artistico erano all'avanguardia, non solo in Italia, altrettanto dal punto di vista politico erano dei principianti. Non avevano cultura politica, non conoscevano altri modi di pensare la società se non quella, illusoria (e molto italiana), dell’uomo forte al comando. Erano una banda di illusi. Ci ha pensato la Storia a deluderli e a disilluderli: di anno in anno racconto come la loro adesione al regime si faccia sempre più labile, fino alla tragedia delle leggi razziali, alla disfatta di Russia, al cataclisma dell’8 settembre 1943 e all’orrore dei campi di sterminio”.
Erano una banda di illusi. Ci ha pensato la Storia a deluderli e a disilluderli: di anno in anno racconto come la loro adesione al regime si faccia sempre più labile.
Gianni Biondillo
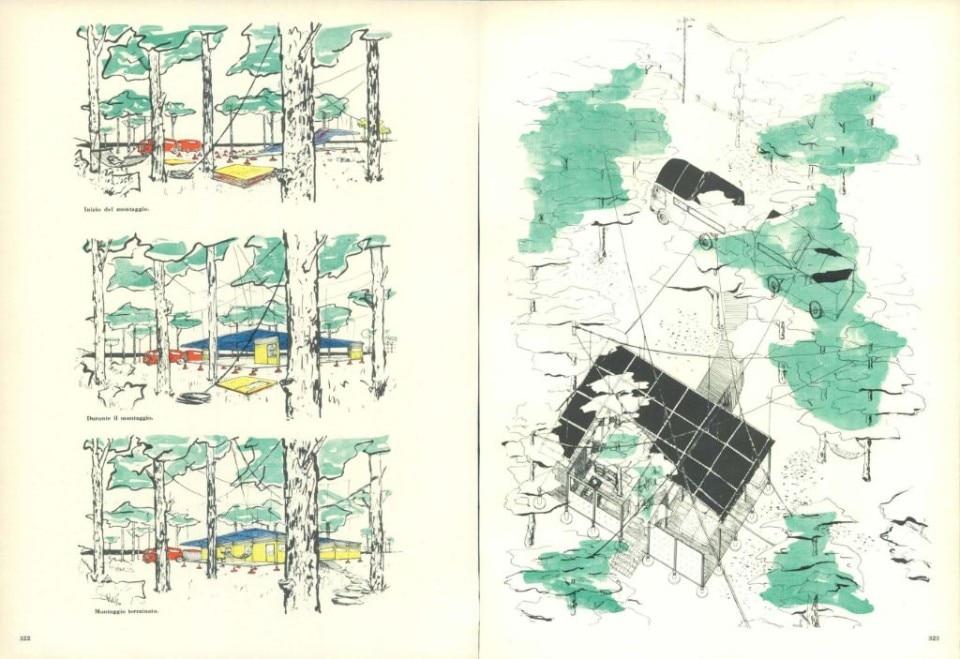
La seconda parte del romanzo, quella che va dagli anni della guerra alla fine del conflitto, è in effetti la più drammatica e dolorosa per i drammi che racconta, per la disumanità dei carnefici, per le tragiche scelte a cui molti dei protagonisti sono costretti nell’agone della Storia. Ma anche qui, Quello che noi non siamo resta un romanzo corale. Non c’è un protagonista che spicchi sugli altri, la bravura di Biondillo sta nell’orchestrare il racconto dando a ciascuno il proprio ruolo e il proprio peso.
“Se qualcuno mi chiede qual è fra i tanti personaggi-architetti il mio preferito – confessa Biondillo – devo riconoscere che faccio fatica a sceglierne uno. Li ho amati tutti come un padre ama i suoi figli. O, meglio, come un discendente ama i suoi antenati. Ognuno mi ha insegnato qualcosa. Avevano difetti e contraddizioni (che racconto senza censure) ma avevano anche talento, visione, rettitudine. Pagano, Terragni, Persico e tutti gli altri, sono tessere di un mosaico che raffigura non un mondo di architetti, ma l’Italia tout court. Io non parlo di architettura in questo romanzo, io uso l’architettura per raccontare il Paese. Amo particolarmente i personaggi femminili, sempre esclusi da questo tipo di narrazioni. Bottoni e Albini sono presenti nel romanzo, ma hanno un ruolo ben inferiore a quello delle loro sorelle. Maria Albini era forse la più inquieta e profonda intellettuale di quegli anni oscuri, Maria Bottoni pagò la sua scelta antifascista fino allo stremo dei campi di concentramento. Eppure, di queste due donne incredibili non si sa praticamente nulla”.

La letteratura, del resto, serve proprio e anche a questo: a riparare alle rimozioni della Storia, a rimettere ordine nel caos, a tracciare mappe e cartografie dei nostri territori culturali ed emozionali. Ma Biondillo – dopo tanti romanzi e tanti racconti – si sente più architetto o più scrittore? La sua risposta è ancora una volta sorprendente: “Sono dell’idea che un architetto sia come un ex-alcolista. Anche se non bevi da anni, rimani un alcolizzato. È una malattia, non se ne esce. Non ho più uno studio da almeno tre lustri, ma continuo a essere iscritto all’Ordine e faccio diligentemente ogni anno i miei crediti formativi. Ogni tanto mi capita pure di fare qualche concorso con amici architetti, giusto per non perdere la mano. Del resto, ogni scrittore ha la sua formazione: ci sono scrittori avvocati, insegnanti, giudici, biochimici, filosofi. Nei libri di ognuno si vede il background culturale da cui proviene. Penso che fra architettura e letteratura ci siano analogie profonde. Penso che Proust non abbia scritto un romanzo, ma che abbia edificato una cattedrale di parole. Alla fine, se dovessi trovare una definizione alle cose che faccio, direi che sono un ‘narratore del territorio’. Insomma: faccio urbanistica sotto mentite spoglie.”



















