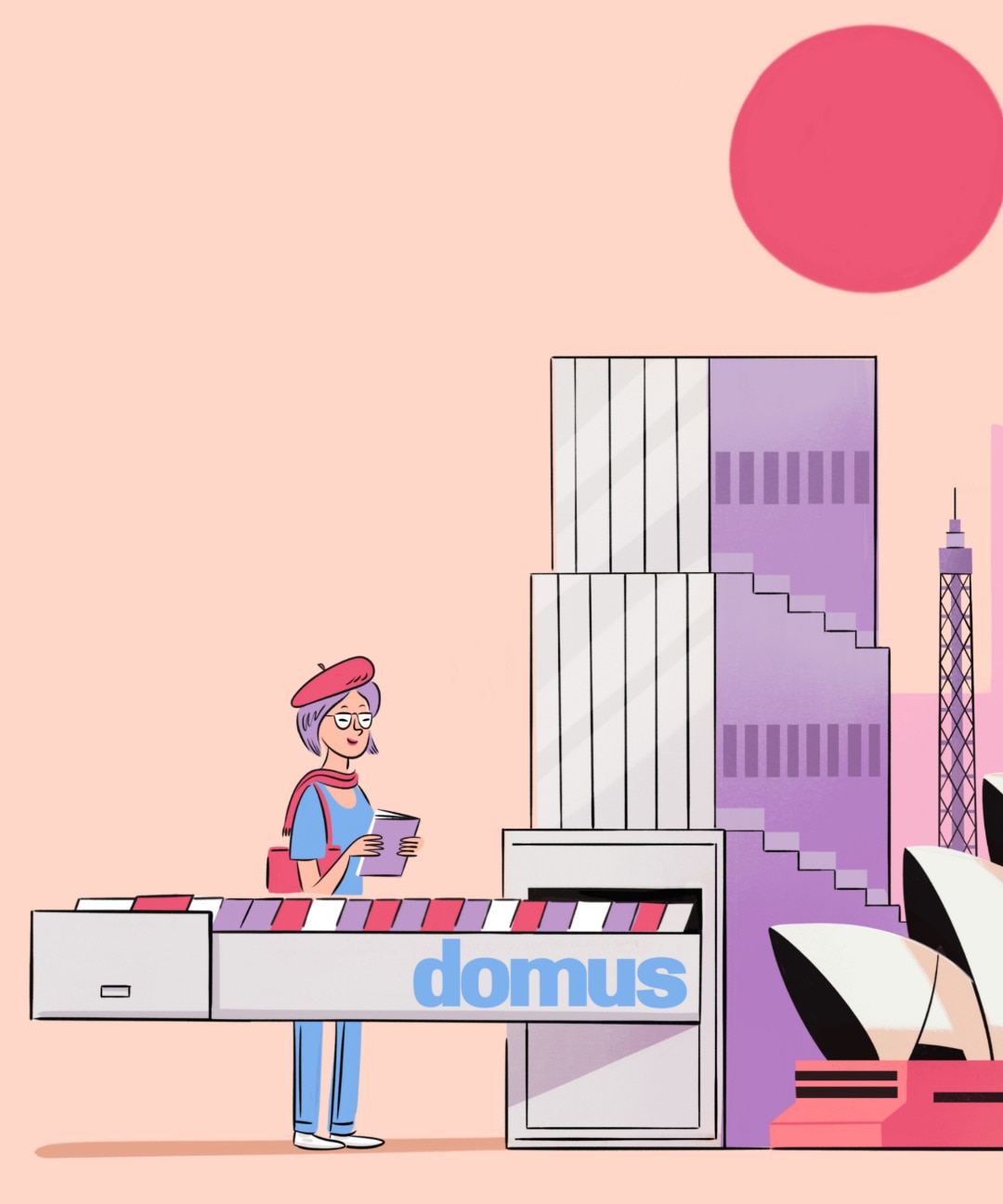“Devo molto alla mia infanzia, che è stata molto avvincente. Ho vissuto cose straordinarie. A essa devo molto della mia formazione. Sono nato a Vitória do Espírito Santo, una città di mare, con un grande porto, una città che non si ferma mai, dove nel porto si lavora sempre. Questa idea del lavoro continuo ha impresso nella mia mente l’idea del lavoro slegata da quella dell’orario. […] Immagina un grande porto, nel quale arrivano e partono navi a tutte le ore, una gigantesca officina perennemente illuminata, come se non ci fosse mai orario, che ci riporta all’idea di Universo… del resto chi naviga non ha orari… Sono nato nella casa dei miei nonni materni. Mio nonno, Serafim Derenzi, era un costruttore di strade di origine italiana. La nostra era una famiglia molto numerosa, due uomini e otto donne. Ricordo quando facevano gli gnocchi. Hai presente il movimento che si fa con le mani e la forchetta?
Ho imparato moltissime cose da mia nonna. Era una donna fantastica. A Vitória faceva molto caldo e in quella casa c’erano tre ghiacciaie. Lei faceva i sorbetti e tutti i nipoti accorrevano a casa sua. A quel punto lei prendeva una sediolina, si sedeva di fronte alla ghiacciaia e si metteva a fare l’uncinetto, altrimenti noi avremmo mangiato i sorbetti prima che fossero pronti... Mia nonna mi ha insegnato cose incredibili. Se ci pensi, erano delle lezioni di termodinamica, calorimetria, meccanica dei fluidi, il tempo come vero e proprio ingrediente d’azione e l’uncinetto e il suo codice, come unità di misura del tempo: non guardava l’orologio, cuciva per un po’. Mio padre era un ingegnere di origini baiane, cresciuto a Rio de Janeiro. Si occupava di ingegneria idraulica. Sono cresciuto vedendo l’ingegnosità delle cose, la possibilità di trasformarle. Mi rendo conto che tutto ciò ha influenzato il mio punto di vista sulla progettazione, sulla relazione tra idea e cosa. L’uomo può trasformare la bellezza che esiste già in una bellezza desiderata e necessaria affinché ci sia la vita e costruisca le città… esiste un rapporto tra crescita naturale e ingegno umano”.
Caro Paulo cerco di districarmi nel meccanismo giornalistico post mortem e, incapace, oggi, di raccontare la tua storia, non posso che riportare qui le parole di quando ti ho conosciuto. Così autentiche e sincere da esprimere con precisione la tua indole, il tuo rapporto con la realtà e col mondo che hai reso migliore con le tue opere.
Paulo Mendes da Rocha avrebbe compiuto 93 anni il prossimo ottobre. Formatosi alla Mackenzie di San Paolo, collaboratore di Vilanova Artigas dagli anni Cinquanta, ha realizzato opere di straordinaria qualità, tutte distinte per il grado di astrazione e sintesi rispetto al tema di progetto oltre che per lo straordinario grado di arditezza strutturale.

Il successo internazionale è arrivato tardi, anche a causa dell’isolamento provocato dai provvedimenti nei suoi confronti da parte della dittatura militare e della concentrazione nello stato di San Paolo delle sue principali realizzazioni. Dopo decenni di silenzio da parte della cultura storico-critica attivatasi solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, pochi giorni fa gli è stato conferito l’ultimo dei tanti (tardivi) premi. Dopo il Pritzker del 2006, il Leone d’oro alla Biennale di Venezia di cinque anni fa esatti, il Premio Imperiale del Giappone del 2016, la Medaglia d’Oro del Royal Institute of British Architects del 2017, la Madaglia d’Oro dell’Unione Internazionale degli Architetti che gli sarebbe stata consegnata il prossimo giugno.
Quella dell’architetto è una ingegneria legata alla vita umana, al luogo che abita. Forse gli architetti sono gli ultimi umanisti.
I premi, tuttavia, non erano ciò che gli interessava. Posso ricordare Paulo Mendes da Rocha con alcuni aggettivi che si riferiscono alla persona che ho conosciuto. La generosità: nel mettere a disposizione il proprio sapere, il proprio tempo, la propria genialità a disposizione di studenti e studiosi, della comunità degli architetti, dei cittadini. L’integrità ideologica e lo sguardo politico: mai un compromesso, mai una scorciatoia, un atteggiamento esemplare dal punto di vista etico. La sua non era un’architettura obbediente, ma un’attività dialettica e didattica, che presuppone cultura e visione, immaginazione e sperimentazione a partire, appunto, dal suo atteggiamento umanista tanto urgente quanto rivolto al futuro: “L’architettura è una forma di conoscenza; non è fantasia. Ciò che caratterizza la visione architettonica è la possibilità di immaginare una cosa costruita, realizzata.
Potremmo dire che l’architetto è un ingegnere particolare e, viceversa, che un buon ingegnere è un particolare architetto. In un certo senso è come se nascessimo architetti; è come se l’uomo fosse incline alla formazione del suo habitat. Quella dell’architetto è una ingegneria legata alla vita umana, al luogo che abita. Forse gli architetti sono gli ultimi umanisti”.

Il suo sguardo era pieno di speranza – “La sapienza è figliola della sperienza” sosteneva Leonardo da Vinci – alimentata dalla conoscenza dello spazio e dei mezzi di trasformazione della natura. Ed è così che, grazie alla sua immaginazione, le travi, nei suoi progetti, si fanno pareti per liberare lo spazio, ogni vincolo strutturale diventa una sfida per raccontare con gentilezza ed eleganza le possibilità della tecnica; il Padiglione del Brasile è un distillato in cui si fondono lirica e tensione strutturale; la palestra del Clube Athletico Paulistano rimarca il suo carattere oggettuale, offrendo alla città di San Paolo il suo primo, eccellente progetto; lo stadio Serra Dourada di Goiânia è un giardino per lo sport; il Museo Brasiliano di scultura di San Paolo è un teatro all’aperto; il Poupatempo Itaquera un grande riferimento civile a grande scala; il SESC 24 de Maio a San Paolo una successione di funzioni che culmina in una piscina che plana sui tetti della città. L’elenco potrebbe continuare all’infinito, lungo i suoi oltre trecentoquaranta progetti (di cui solo quaranta costruiti).
Quando raccontava alcuni progetti capitava dicesse “come se fosse una Venezia”. Ecco che Venezia non era la città, ma un teatro, un luogo mentale, un miracolo fatto dall’uomo per la felicità dell’uomo, in dialettica con una condizione naturale. Il suo amore per questa città era una costante rintracciabile nelle sue più importanti formulazioni concettuali che stanno alla base del progetto. La sua abilità che potremmo dire registica, visionaria, radicale ci mostra un modo di pensare e agire in nome di una disciplina che merita di riconquistare la dignità collettiva che per sua stessa definizione la contraddistingue. Non solo: nel tempo in cui la complessità parrebbe inghiottire il pensiero e avanza – questo era uno dei suoi timori – la peggiore architettura supina alla speculazione, Mendes da Rocha lascia in eredità il suo pensiero fatto di densità e profondità, espresso – come nei suoi progetti – con la leggerezza che lo contraddistingue, la sua musicale nonchalance.
Caro Paulo, la tua architettura è stata definita senza tempo, eterna, priva di ogni retorica; un'architettura dove l’uomo sta sempre al centro. Tellurica, classica e insieme condannata alla sua perenne modernità, penso al suolo del tuo capolavoro, il Padiglione del Brasile a Osaka. Penso alla canzone di Sílvio Caldas Chão de Estrela – Nossa cidade aberta / E o que nos resta / É celebrar: La nostra città aperta, ciò che ci resta è la sollennità del ricordo.
Non dimenticheremo mai la tua lezione, quella tua città per tutti che rimarrà eterna, come la tua opera piena di vita.
Immagine di apertura: Tudo è Projeto, fotogramma, 2017

L’energia del domani nasce dalle idee di oggi
Enel lancia un contest internazionale “WinDesign” per immaginare il nuovo design delle turbine eoliche.