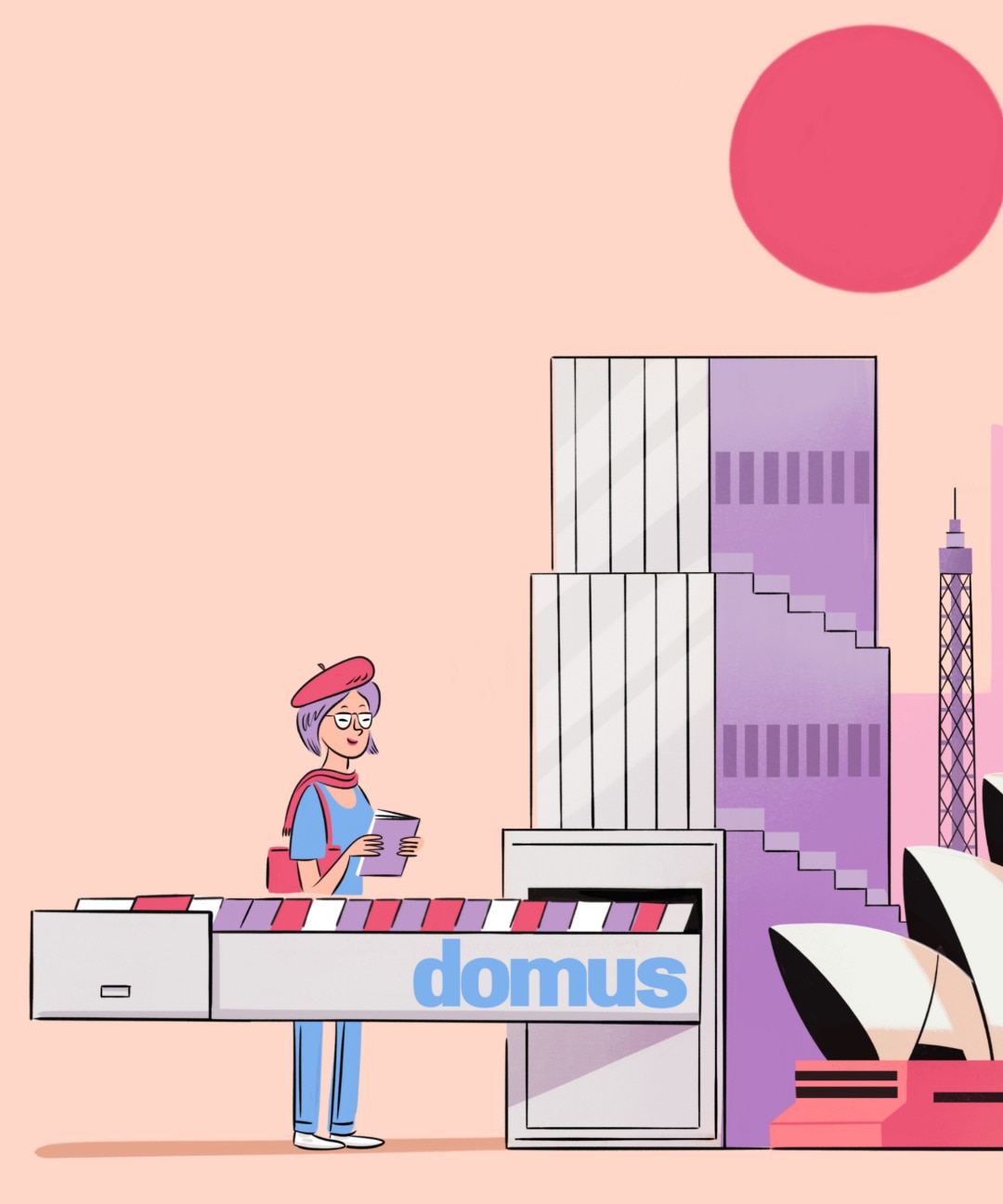fino al 12 gennaio 2015
Arata Isozaki 12x5=60
Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo

Sahil: l'eco-design di G.T.DESIGN
Alla Milano Design Week 2025, G.T.DESIGN presenta Sahil, una collezione di tappeti in juta firmata da Deanna Comellini. Il progetto combina sostenibilità, artigianato e design essenziale, ispirandosi a culture nomadi e celebrando la naturale bellezza della materia.