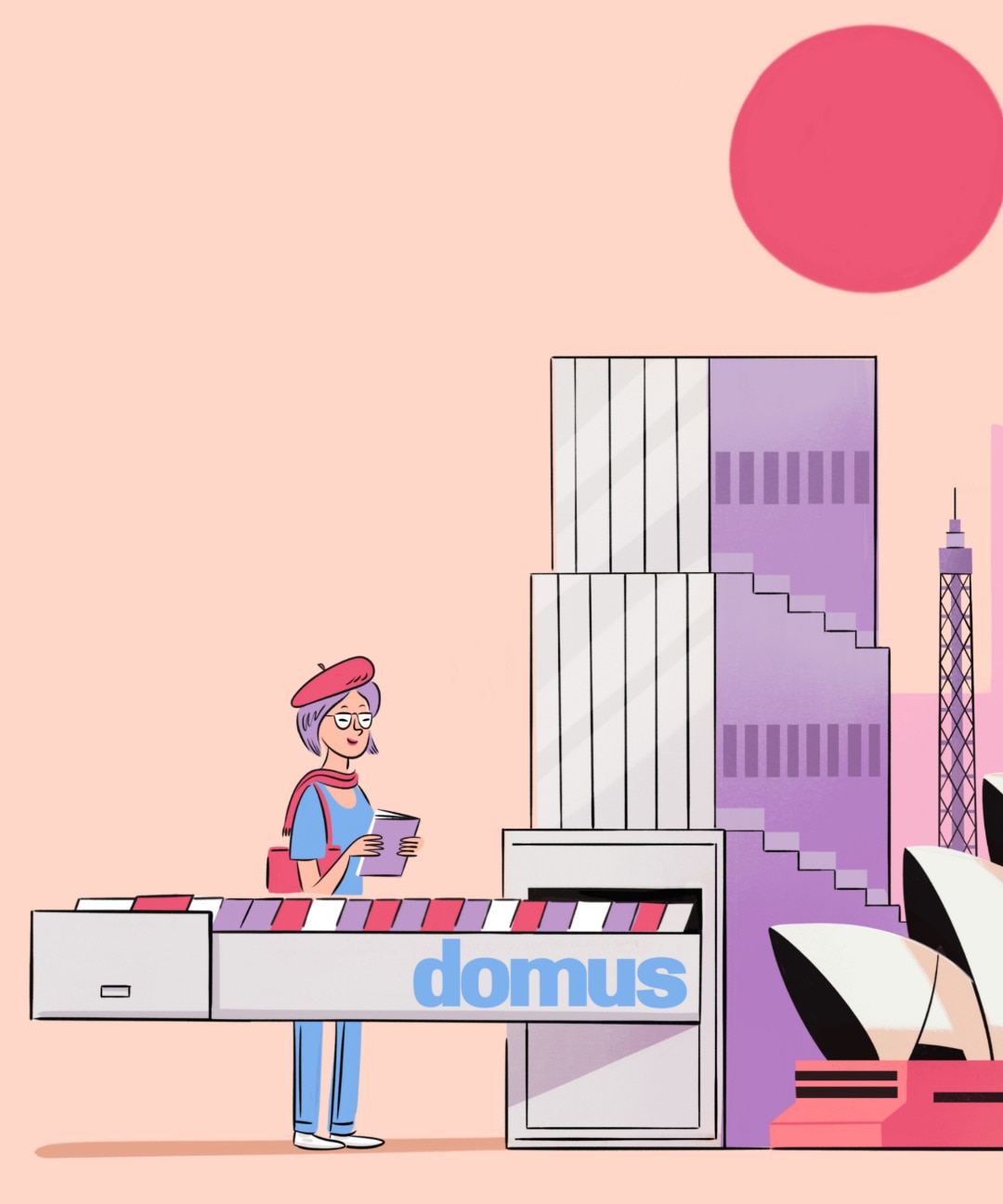La lunga carriera di Aurelio Galfetti, uno dei nomi più importanti della cosiddetta scuola ticinese con tra gli altri Luigi Snozzi, Mario Botta, Flora Ruchat-Roncati e Livio Vacchini, ha abbracciato dai primi anni ‘60 una molteplicità di luoghi, scale e tipologie di intervento, ma è proprio il Canton Ticino ad aver sempre costituito un baricentro del suo lavoro e della sua ricerca. È lì, a Mendrisio, che fonderà con Botta l’Accademia di Architettura; è che con Ruchat aveva realizzato il complesso scultoreo e paesaggistico del Bagno di Bellinzona; ed è lì, proprio a Bellinzona, che nei primi ‘80 Galfetti riceve l’incarico di restaurare e riattivare uno dei tre castelli della città. Il risultato è un posizionamento peculiare rispetto alla stessa teoria e pratica del restauro: è sull’intera collina del castello che si interviene – facendone nuda roccia sulla piazza bassa e vigne tutt'attorno – mentre il progetto, là dove non si nasconde direttamente dentro la roccia, non sarà mimetico ma anzi darà espressioni contemporanee molto forti a tutto il complesso. A lavori completati, nel giugno del 1993, Domus pubblica il Castelgrande sul numero 750.
.png.foto.rmedium.png)
Il restauro di Castelgrande a Bellinzona
L’intervento a Castelgrande ci interessa in primo luogo in quanto Galfetti ha utilizzato gli strumenti disciplinari propri del progetto architettonico per uno specifico lavoro di restauro. Il progetto è stato applicato coinvolgendo direttamente l’esistente e non, come spesso avviene, a lato di esso. La memoria è allora oggetto e strumento del progetto stesso, e il rapporto vecchio-nuovo insolubile. Un atteggiamento che considera in pratica il restauro come uno degli sbocchi del normale processo progettuale, cioè soprattutto come un’operazione attiva e non passiva, creativa e non tecnica, un atteggiamento insomma che lo rende partecipe a pieno titolo alla disciplina.
La memoria è allora oggetto e strumento del progetto stesso, e il rapporto vecchio-nuovo insolubile.
Castelgrande, uno dei tre castelli di Bellinzona, è posto su una piccola collina rocciosa al centro della città, che abbraccia con le lunghe mura, ma da cui morfologia e assenza di funzioni lo avevano progressivamente allontanato. Si trattava quindi di integrare e restituire questa fortificazione alla città. Galfetti ha deciso di intervenire su tutta la collina coerentemente con la dimensione urbana che doveva assumere il progetto. Ha in primo luogo ripulito completamente la roccia dalla vegetazione che l’aveva aggredita e che impediva la percezione del castello dal basso.
.png.foto.rmedium.png)
Così sul lato est una grande parete rocciosa ha assunto il ruolo di facciata del castello verso la città, come un segno della storia del luogo in senso geologico, insinuando il dubbio se si tratta di elemento naturale o artificiale. Sull’altro lato invece il terreno scosceso è sistemato, per mediare il dislivello, con terrazzamenti a vigna la cui geometria si pone in tensione tra le curve esistenti. Il nuovo paesaggio è dunque costruito, progettato; e si compone di tre soli elementi: prato, roccia e mura. Il parco che si estende sulla collina intorno al castello presenta solo tre alberi, quasi fossero oggetti in mostra, elementi precisi del nuovo disegno secondo una rappresentazione che, ancora una volta, induce a mescolare e invertire i concetti di artificiale e naturale. Il progetto è capace di rendere naturale l’artificio o artificiale la natura.
.png.foto.rmedium.png)
Al castello si può accedere da una passeggiata sulle mura, oppure percorrendo il sentiero che sale intorno alla collina, oppure tramite un ascensore scavato nella roccia (si tratta dell’entrata principale). Splendido esempio di architettura scavata – non costruita – questo accesso obbliga a penetrare la roccia in una fessura dove anche la luce stenta ad entrare. Qui l’utilizzo di un ascensore, che normalmente nega la percezione delle distanze appiattendo la relazione spazio-tempo, è trasformato sapientemente in percorso architettonico. In alto, all’uscita dell’ascensore, una larga rampa che divide le mura del castello da un muro di contenimento del nuovo terrapieno conduce all’ampio spazio centrale sistemato a prato su cui si affacciano tutte le costruzioni.
Un restauro creativo lavora sul manufatto storico senza considerarlo un elemento sacro inviolabile. In fondo cosa significa autenticità dell’antico? Cos’è l’antico? Dov’è il limite?
Le facciate intonacate conferiscono un carattere quasi di piazza ma l’estrema rigidità dell’insieme è più astratta che urbana, con un albero – poeticamente solitario – e sull’altro lato le due torri del secondo Medioevo enfatizzate dal nuovo deciso piano orizzontale. Tutte le parti edificate, anche quel-le storicamente meno importanti, sono state ristrutturate anche attraverso completamenti o rifacimenti. Il corpo di fabbrica principale si compone di tre elementi: l’ala sud, di forma poligonale (’400-’600); l’ala dell’ex arsenale, un unico parallelepipedo (’800) e infine un corpo di raccordo tra i due, più alto (fine ’800). In quest’ultimo trova posto l’atrio d’ingresso per tutte le diverse strutture, che sono un ristorante e una sala conferenze/banchetti (ex arsenale); un museo storico e un bar (ala sud).
.png.foto.rmedium.png)
L’atrio è un unico alto ambiente ricavato svuotando il manufatto dalle solette; un’operazione questa che ha lasciato sul muro verso valle le tracce delle diverse stratificazioni storiche. La sua copertura è molto pendente per risolvere la differenza di altezza dei due fronti (a valle e sul cortile). Questo problema tecnico è lo spunto per la sua espressione architettonica, infatti un telo appeso al soffitto dinamizza questo spazio, connotandolo in modo particolare, e ne identifica in fondo il carattere intermedio tra le due ali. Il ristorante ed il museo sono organizzati come sequenze lineari di locali, e presentano poche aperture quali punti di vista verso la città. Gli interni si caratterizzano attraverso i materiali, cemento e pietra naturale, accostati con eleganza di proporzioni, forme e colori.
Anche il legno, utilizzato per i nuovi solai, è stato dipinto di nero per corrispondere a quella scala cromatica di soli grigi (dal bianco al nero) che contraddistingue tutto il progetto. Sono comunque la plasticità del cemento e la linearità della pietra a definire un’architettura – fatta dalla materia – che non distingue struttura originaria, ricostruita o progettata. Approccio questo molto diverso per esempio da quello che nel restauro di un altro castello di Bellinzona avevano adottato negli anni ’70 Campi, Pessina e Piazzoli, separando nettamente il nuovo intervento dall’esistente. Non è una tendenza dei nostri giorni, ma una precisa filosofia di Galfetti per il quale conservare significa sempre trasformare, dunque il restauro non è solo recupero ma soprattutto adeguamento. Recuperare vuol dire anche rendere utilizzabili i luoghi. La contemporaneità di ogni trasformazione è data dalla corrispondenza funzionale alle esigenze del proprio tempo (Zeitgeist). Queste considerazioni – che non valgono evidentemente per i monumenti la cui importanza architettonica prevarica la funzione – valgono specialmente per un esempio come Castelgrande, nato come struttura di difesa ma ormai inutile e fatiscente, divenuta di svago.
.png.foto.rmedium.png)
Il restauro creativo che si contrappone a quello conservativo è anche spaziale, stabilendo inoltre un legame architettura-funzione, ma non una corrispondenza forma-contenuto. Un restauro creativo lavora sul manufatto storico senza considerarlo un elemento sacro inviolabile. In fondo cosa significa autenticità dell’antico? Cos’è l’antico? Dov’è il limite?
Castelgrande è un insieme di innumerevoli interventi successivi iniziati probabilmente quattro millenni fa, ognuno dettato dalle esigenze e dalla cultura della propria epoca. Quella di Galfetti non è altro che l’importante traccia lasciata dalla fine del XX secolo, e non sarà l’ultima. Oggi questa opera – grazie anche a una decisa volontà politica – dà un apporto concreto a Bellinzona. Dall’alto di una collina stabilisce, quale luogo pubblico, un forte legame architettonico e sociale con la città, e ne diviene il principale punto di riferimento. Una nuova acropoli.