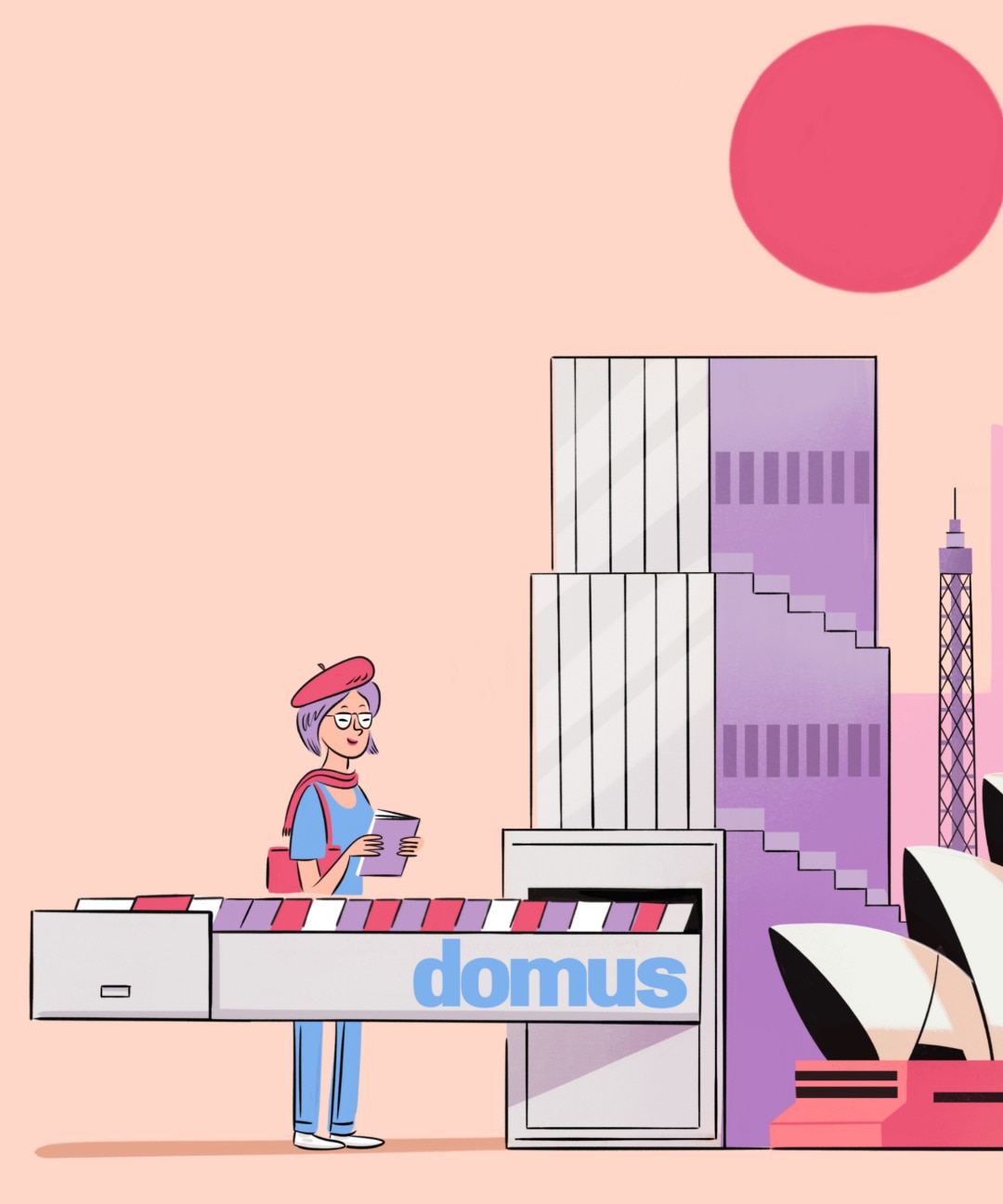Nato alla metà degli anni ‘80 in Francia e praticato soprattutto in ambito urbano, si può dire che il parkour consista fondamentalmente nello spostarsi da un punto di partenza a un punto di arrivo, usando solo il proprio corpo e gli elementi dell'ambiente circostante. La parola parkour deriva dai parcours du combattant proposti come addestramento militare dal militare francese Georges Hébert.
Spesso viene visto solo come un gioco, invece è una vera e propria arte, l’art du déplacement (suo primo originario nome) che letteralmente significa arte dello spostamento, perché è proprio nel movimento del corpo e con esso che i traceurs e le traceuses (così sono chiamati gli atleti) svelano le opportunità nascoste dello spazio, spesso proprio a partire dai suoi limiti, trasformando gli ostacoli in stimoli all’esplorazione e alla creatività.

In qualità di cultori dello spazio e della città viene spontaneo chiedersi se questo sguardo offerto dal parkour, possa essere d’ispirazione per nuovi scenari urbani. Lo abbiamo chiesto all’architetto e designer Mikkel Rugaard, traceur esperto con una laurea in educazione fisica e un master in architettura e design industriale. Mikkel è uno dei pionieri del parkour design, ed è stato coautore dello standard europeo per le attrezzature da parkour molte delle quali disegnate dal suo studio. Viso affilato, sguardo acuto e parlantina vivace, accoglie Domus, in un’intervista mattutina, con una posizione molto chiara sulla questione e che di primo acchito risulta sorprendente: “per il parkour la città è solo una circostanza, le persone lo interpretano solo come un fenomeno urbano, ma non è così. Non sono le caratteristiche spaziali a determinare la pratica di un traceur, ma la sua capacità di interpretare il contesto in modo creativo”.
Andiamo a fondo della questione svelando quanto invece potenzialmente sia la città a dover cogliere l’occasione offerta dal parkour nel “stimolare le persone a pensare in modo diverso, nell’ispirarle al movimento, cosa peraltro fondamentale per la salute, nel dimostrare che superare i limiti è possibile e che portare nello spazio cose inaspettate è un potenziale. Nel mio lavoro mi occupo di spazi e oggetti per il corpo umano in movimento: la mia pratica spazia dallo sviluppo del concetto alla produzione e all'esecuzione, dall'oggetto al paesaggio”.
Non sono le caratteristiche spaziali a determinare la pratica di un traceur, ma la sua capacità di interpretare il contesto in modo creativo.

Da un certo punto di vista è come se i traceurs offrissero l’opportunità di riportare il corpo al centro dello spazio, come strumento di conoscenza dello stesso e come misura della sua qualità, e fornissero gli strumenti per alimentare quella creatività spaziale che tanto manca soprattutto allo spazio publico che molto spesso è rigido e privo di visione. Una critica mossa anche da Paolo Sendra e Richard Sennet che nel recente Progettare il disordine, sottolineano quanto “riuscire a pensare spazi urbani che, all’occorrenza, sappiano andare oltre la funzione, permettendo alle persone di immaginare e di sperimentare usi e attività inaspettate, è fondamentale per migliorare la loro relazione con l’ambiente e per sviluppare quel senso di appartenenza alla città che sta alla base della tanto ambita sostenibilità”.
Anche su questo concetto di sostenibilità Mikkel offre uno spunto molto interessante: “Sono un fan dell’interdisciplinarietà intesa come rispetto delle altre discipline; rispettare competenze, conoscenze, senza arroganza, è un modo sostenibile di approcciarsi alle cose. Per esempio, il fatto che io sappia parlare tante lingue, quella dell’architetto-designer e dell’atleta, e che sappia comprendere questioni tecniche, economiche, progettuali, mi ha permesso di sviluppare una sensibilità al contesto e di restare in contatto e di interpretare le necessità di tutte le dinamiche che si sviluppano intorno ad uno spazio. Dedico molto tempo alla comprensione di un luogo e di ciò che avviene intorno”.
Ci vuole tempo e pazienza, non possiamo pretendere che il cambio di prospettiva arrivi da un momento all’altro.
Questa fusione tra design-città e parkour, di cui Rugaard è pioniere, è molto giovane. L’attività del suo studio è fiorente in Danimarca, meno all’estero, anche se iniziano ad arrivare occasioni progettuali anche d’oltreoceano, ma specifica: “anche se è ancora molto difficile essere invitati ai tavoli di progetto, credo che, così com’è stato per lo skate, anche i traceurs a poco a poco riusciranno ad essere riconosciuti come attori urbani. Ci vuole tempo e pazienza, non possiamo pretendere che il cambio di prospettiva arrivi da un momento all’altro”.
La strategia, quindi, è quella di instillare con pazienza, in chi vive e progetta l’ambiente urbano, la curiosità e la visione che una città sostenibile ha bisogno di corpi in movimento, di luoghi capaci di adattarsi e di evolversi per diventare più intelligenti e consapevoli del loro presente e del loro futuro.

Sahil: l'eco-design di G.T.DESIGN
Alla Milano Design Week 2025, G.T.DESIGN presenta Sahil, una collezione di tappeti in juta firmata da Deanna Comellini. Il progetto combina sostenibilità, artigianato e design essenziale, ispirandosi a culture nomadi e celebrando la naturale bellezza della materia.